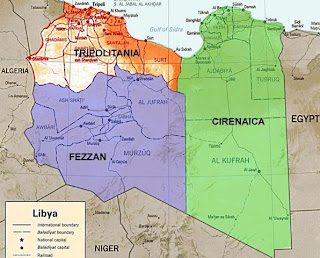di Ettore Masina
Sono trascorsi trent’anni dal martirio di Monseñor. Il popolo salvadoregno è rimasto fra i più miseri della Terra, l’80% della sua popolazione vive sotto il livello della povertà, la disoccupazione è altissima, le potenzialità turistiche della sua economia (El Salvador è un paese meraviglioso di vulcani e di laghi, di spiagge, di buon clima) sono bloccate dal proliferare del narcotraffico e di una criminalità giovanile organizzata per bande (le maras), alimentata dalla miseria: 4 mila 365 morti nel 2009. Il fenomeno è così grave che negli ultimi tempi in certi ambienti della polizia e dell’esercito sono riemersi nuclei di squadroni della morte che pretenderebbero di risolvere il problema con le armi. Adesso, tuttavia, il governo è ben lontano dall’accettare una politica del terrore. El Salvador, infatti, è finalmente una democrazia, schiacciata dalle terribili eredità della guerra civile (e naturalmente dalla crisi economica mondiale), ma guidata da persone oneste e desiderose di costruire strade di giustizia. Nelle elezioni del marzo 2009 la destra è stata sconfitta ed è stato eletto presidente il candidato del FLMN, trasformato in partito: Mauricio Funes, 51 anni, giornalista, con una faccia rotonda e paciosa, un uomo intelligente e coraggioso, anche lui marchiato dalla tragedia della guerra civile perché un suo fratello è stato ucciso dai militari. Prima della cerimonia del suo insediamento, Funes è sceso nella cripta della cattedrale di San Salvador in cui è sepolto l’Arcivescovo, per rendere omaggio alla sua memoria. Poi il nuovo presidente è andato all’aeroporto internazionale; davanti a un grande “murale” in cui Oscar Romero è raffigurato in mezzo a un gruppo di bambini, Funes, a nome dello Stato, ha chiesto perdono per il suo assassinio (…).
Così Oscar Romero continua a essere una guida per il suo popolo, anche se dopo la morte di lui il popolo salvadoregno si è demograficamente “rinnovato”: ben più di metà degli abitanti è nata dopo quel terribile marzo 1980, mentre sono morti almeno 400 mila dei salvadoregni che lo acclamarono santo.
Tuttavia non si può parlare di questo piccolo grande vescovo come di un personaggio soltanto salvadoregno e neppure soltanto cattolico. Molte Chiese (da quella luterana a quella vetero-cattolica) celebrano ogni anno il suo sacrificio; nel 1998 la regina Elisabetta ha presenziato alla cerimonia con la quale gli anglicani gli hanno eretto una statua sulla porta occidentale di Westminster, accanto alle immagini di altri nove “martiri del Novecento”: Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Massimiliano Kolbe... Un'altra effige di lui è stata posta nella National Cathedral (episcopaliana) a Washington. Si calcola che siano almeno un milione le case dell’America del Nord in cui si trova la riproduzione di un ritratto dell'arcivescovo, opera del pittore Robert Lentz, un frate francescano americano (...).
A chiedere perché mai il martire non sia stato ancora proclamato santo è certamente una immensa folla di credenti: ma attendono una risposta a questo inquietante interrogativo anche molti e molte che pure non si definirebbero cristiani, uomini e donne i quali pensano che la violazione e la difesa dei diritti umani segnano, profondamente, la nostra civiltà; e si domandano perché la Chiesa cattolica non si mostri orgogliosa di questo suo figlio. (…).
I vescovi latino-americani riuniti a Roma nel Sinodo del 1997 hanno chiesto che la causa del loro confratello venisse rapidamente istruita. Sono passati tredici anni, risposte: nessuna. Nel trentesimo anniversario dell’uccisione, i vescovi del Salvador hanno ripetuto la richiesta. Scrivo queste righe nel febbraio dell’anno 2011. Sino ad oggi, risposte: nessuna. (...). Durante il suo pontificato Giovanni Paolo II ha proclamato più di milleottocento tra santi e beati. Ma Romero, no. (…).
ABBIAMO BISOGNO DI “SANTI VIVI”
Certamente il caso di Oscar Romero è del tutto singolare. Egli fu assassinato mentre celebrava una messa, e perciò i suoi fedeli lo definirono martire. Tuttavia, secondo qualche “esperto”, per essere considerato tale gli manca un requisito: quello di essere stato ucciso in odium fidei, da qualcuno che odiava la fede cattolica. Odio ci fu, dicono i sostenitori di questa tesi, ma politico: i mandanti dell’assassinio e probabilmente lo stesso carnefice credevano di essere buoni cattolici e di avere compiuto il loro delitto per il bene della Chiesa, che Romero e il suo popolo inquinavano con il loro “comunismo”. Del resto quasi tutti gli altri vescovi salvadoregni (tutti, tranne il successore di Romero, Rivera y Damas) condividevano, più o meno consciamente, questo giudizio. Un collaboratore - e amico - dell’Arcivescovo mi ha raccontato che nel secondo viaggio di Wojtyla a San Salvador (1996), Giovanni Paolo II domandò ai vescovi che pranzavano con lui nella sede della Nunziatura cosa pensassero di una canonizzazione di Romero: «Subito monsignor Revelo disse che sarebbe stato un grande errore, Romero era il responsabile dei 70 mila morti della guerra civile. La brutalità di questa affermazione non piacque al papa, che tolse bruscamente la parola a Revelo. Ma anche altri parlarono contro Romero. Il pontefice si mostrò irritato e cambiò discorso… Pensai allora - concluse il mio interlocutore - che la canonizzazione dell’arcivescovo non sarebbe avanzata sino a che quei vescovi antagonisti non fossero morti». Da allora, tutti questi alti ecclesiastici si sono spenti. Ultimo, monsignor Revelo, nell’anno 2000. Il Vaticano ha continuato a tacere.
La questione del martirio, comunque, sembra risolta perché proprio Giovanni Paolo II l’aveva superata già nel 1982, proclamando la santità di Maximilian Kolbe, il francescano polacco che, nel lager di Auschwitz, salvò la vita di un padre di famiglia condannato a morire nel bunker della fame, sostituendolo. Wojtyla parlò allora di «martire della carità». (…). E fu proprio Giovanni Paolo II, in una cerimonia giubilare al Colosseo, il 7 maggio dell'anno 2000 a catalogare l'arcivescovo di San Salvador fra «i nuovi martiri» (...).
Questo riconoscimento fu espresso dieci anni fa: evidentemente alla Congregazione dei Santi neppure la parola di Giovanni Paolo II è bastata.
Molti vescovi, del resto, hanno applicato e applicano oggi la definizione di martire all’arcivescovo di San Salvador, per esempio il cardinale Martini, che ha detto: «Romero è stato un martire della giustizia, della verità e della carità». (…).
Per chi non è cattolico o non crede nella necessità dell’intermediazione dei santi, la questione della canonizzazione rimane pur sempre importantissima da un punto di vista “generativo”: risiede nella possibilità della Chiesa di proporre modelli di comportamento particolarmente vicini alla radicalità evangelica.
Ho raccontato di non avere potuto andare a pregare sulla tomba di Romero, all’epoca del mio viaggio (gennaio-febbraio 1992), perché la cattedrale era chiusa per lavori in corso. Vero, ma poi ho saputo che c’era anche un’altra ragione: su richiesta della nunziatura, i lavori, pur necessari, offrivano la possibilità di bloccare quello che veniva definito un culto pubblico di Monsignore, cioè la pratica affermazione della sua santità da parte di gruppi di fedeli. Che la Chiesa cerchi di impedire il più che possibile diffondersi di superstizioni, nella devozione a “santi” che in realtà furono soltanto degli invasati o degli imbroglioni, questo è ovviamente legittimo e spesso provvidenziale. Però a me sembra anche di grande importanza quanto è scritto in un documento salvadoregno: «(…) Crediamo che non basti appellarsi alle norme dei processi di canonizzazione che vietano un culto pubblico. In primo luogo, è difficile, se non impossibile, che la gente comprenda il concetto e le sue finalità. Ma, più profondamente, bisogna riconoscere che (...) se il “fenomeno Romero” è autentico, è inutile tentare di “privatizzare” il suo ricordo (...). E se Monsignore è necessario (...), non è cosa buona provvedere a tenerlo muto per alcuni anni, fino a quando sia canonizzato, perché è adesso, in questi anni, che abbiamo bisogno della sua ispirazione e del suo coraggio. Non abbiamo bisogno di santi “morti”, canonizzati quando nessuno li conosce e la loro parola non è più attuale, abbiamo bisogno di santi “vivi” che animino i cristiani qui e ora...». (…).
EFFETTI COLLATERALI
Romero ha tempestato il Vaticano di messaggi e di dossier. Perché nessuno ha saputo leggerne la terribilità della situazione del Salvador e dell’Arcivescovo? Quali informazioni (e date da chi) giungevano da San Salvador? E che cosa veniva “passata” al pontefice da chi era incaricato di riassumergli la documentazione? Gli incontri fra Romero e il suo papa sono segnati da ombre che si interpongono fra i due.
Certamente la guerra fredda ne aumenta il gelo.
La situazione della Chiesa nei paesi dell’Est, in seguito agli accordi di Yalta, era stata per anni segnata dalla ottusa brutalità del comunismo sovietico. Giovanni XXIII e Paolo VI avevano avviato con quei regimi un cauto (o cautissimo) dialogo. Quando fu eletto il papa polacco, nell’ottobre del 1978, l’impero sovietico cominciava a scricchiolare, e l’accorta politica “della pazienza”, portata avanti dal cardinale Casaroli, dava i primi frutti, ma la libertà religiosa in quegli Stati era ancora una meta lontana (...). Fu ben presto chiaro che la sofferta esperienza di tanti anni di confronto con il comunismo avevano maturato in Karol Wojtyla due convinzioni. La prima, che l’unità dei vescovi di una nazione era un valore assoluto, l’unica garanzia per la libertà della Chiesa. La seconda (che egli attenuò in seguito, dopo il 1989), era la seguente: che mentre le dittature comuniste miravano ad essere definitive e radicalmente anticristiane (perciò il Nemico per antonomasia), le dittature “di destra” (militari e no) potevano essere considerate provvisorie, forme di governo richieste in periodi difficili della storia. (…).
Le dittature installate in quegli anni nell’intero continente esibivano un cerimonioso rispetto per la Chiesa cattolica e un’attenta cura alla conservazione dei suoi privilegi. Erano sostenute - o, come nel caso del Salvador, dirette - da quei grandi ricchi che le gerarchie locali e il Vaticano avevano considerato per secoli benefattori e difensori. Quei regimi colpivano gli oppositori con grande violenza (istituzionale o affidata a polizie segrete, a formazioni paramilitari) - e fra questi oppositori v’erano anche non pochi cattolici e perfino sacerdoti - ma i nunzi pontifici, i quali mantenevano generalmente ottimi rapporti con i governanti, garantivano al Santo Padre che certi tristissimi episodi erano, per così dire, le inevitabili scorie di un disegno politico inteso a difendere i valori della cultura cristiana dalla minaccia comunista. Anche la diplomazia degli USA denunziava il non allineamento o addirittura l’ostilità di movimenti cattolici nei confronti della sua influenza economica e politica. Nella sua enciclica Populorum progressio, del resto, papa Montini aveva (26 marzo 1967) condannato «l’imperialismo internazionale del danaro» e ammesso, in casi estremi di tirannia, la liceità di una rivoluzione popolare.
ROMERO È NOSTRO
I vescovi cattolici che presiedono diocesi sono più di 2 mila 700. Il nuovo papa deve imparare a conoscerli tutti, loro e i loro problemi. Romero è per Wojtyla un ignoto. L’Arcivescovo non ha partecipato al Concilio, che è stato un momento in cui molti “padri” hanno imparato a conoscersi e fra loro sono nate amicizie e solidarietà. È la Curia vaticana a fornirne un identikit. Certamente non può riuscire gradito al nuovo papa un presule che rompe l’unità episcopale del suo paese e che si permette, scavalcando ogni vertice vaticano, di scrivere, a nome proprio, al presidente degli Stati Uniti. Fra l’elezione di Giovanni Paolo II e l’assassinio di Romero corrono un anno e 5 mesi, un tempo troppo breve perché nasca un rapporto di mutua comprensione fra due pastori che devono annunziare il vangelo in un mondo stravolto da drammatiche tensioni. Si può forse comprendere perciò che il papa veda nel delitto di San Salvador soprattutto un attacco alla Chiesa, alla dignità episcopale e un grave sacrilegio. In un’intervista rilasciata a Mario Ponzi, il cardinale Roberto Tucci s.j., organizzatore dei viaggi di Giovanni Paolo II, racconta quanto avvenne nel 1993 a San Salvador: «Papa Wojtyla nell'affrontare situazioni difficili, a volte anche scabrose o pericolose, era testardo. Come dimenticare la sua determinazione nel voler pregare a tutti i costi sulla tomba dell'arcivescovo Oscar Arnulfo Romero a San Salvador? Ignorare quella tomba era stata una delle condizioni poste dal Governo per acconsentire alla visita. I vescovi sconsigliarono il Papa di andare. Non ci fu nulla da fare: Giovanni Paolo II voleva farlo perché si trattava di un vescovo ucciso mentre celebrava l'Eucaristia. Quando arrivammo sul posto, trovammo la cattedrale sprangata. Il Pontefice si impuntò e disse che non si sarebbe mosso di lì fino a che non gli fosse stato consentito di pregare su quella tomba. (…)».
Secondo alcuni testimoni, ponendo le mani sulla tomba, Giovanni Paolo II esclama: «Romero è nostro». L’importanza attribuita dal papa a questa cerimonia contrasta evidentemente con la sobrietà della definizione che egli dà di Romero: «Zelante pastore». È una definizione che Wojtyla manterrà in tutte le occasioni, anche quando accetta di inserire il nome dell’arcivescovo nell’elenco dei martiri del nostro tempo. La canonizzazione di Monsignore non è certo una priorità nell’agenda del nuovo papa. La Curia ne tiene conto. Il pontificato di Giovanni Paolo II dura 27 anni.
LA LAMPADA SOTTO IL MOGGIO
C’è un’accusa che la curia vaticana rivolge a Romero come ad altri vescovi dell’America Latina, ed è quella di essere un sostenitore della Teologia della Liberazione che va diffondendosi alla fine degli anni ‘70. Si potrebbe definirla una teologia continentale, nel senso che tenta di elaborare un’espressione della fede distaccata dalla tradizione europea (e vaticana!) e più aderente alla specificità del luogo e della sua storia. «Individua nel povero come soggetto storico il locus theologicus di una riflessione che vede nella fine della schiavitù narrata dall’Esodo e nella marginalità oppressa di Gesù di Nazareth una lente con cui interpretare il destino storico e spirituale delle masse diseredate (…). Per papa Wojtyla l’adozione dell’analisi e del vocabolario marxista che viene compiuta (con accentuazione diversa) dai teologi (…) è inquietante (…). Per lui ogni evocazione del pensiero marxiano inquina il desiderio di giustizia, corrompe l’immagine del povero riducendola all’ideologia di classe e alla fine diventa un cedimento alla propaganda comunista» .
Che c’entra Romero? Il fatto è che uno dei centri di elaborazione della Teologia della Liberazione è a San Salvador, in quella UCA dove, nel 1986, si è compiuta la strage dei gesuiti, ai quali l’Arcivescovo era legato da amicizia e collaborazione. Gli uomini di punta di quel gruppo erano Ignacio Ellacuria e Jon Sobrino. Ellacuria è stato bestialmente massacrato, Sobrino, invece, in quel periodo era all’estero e si è salvato. Salvo, ha continuato la sua ricerca teologica ma ha anche deciso di lavorare per la canonizzazione di Romero. È facile capire che con un “procuratore” del genere, più volte ammonito dal cardinale Ratzinger cui Giovanni Paolo aveva affidato l’ex Sant’Offizio, a Roma la “causa” dell’Arcivescovo abbia dovuto superare intoppi. Il 20 marzo 2004 l’arcivescovo di San Salvador Fernando Sáenz Lacalle ha annunciato in una conferenza stampa che il processo di beatificazione, avviato nel 1994, «è ancora in una fase iniziale, poiché, da quanto ho capito, il caso non è passato alla Congregazione per la Causa dei Santi: si trova ancora alla Congregazione per la Dottrina della Fede». (…).
In viaggio per il Brasile, il 9 maggio 2007, i giornalisti pongono a Benedetto XVI la domanda che tante volte avevano posto a Giovanni Paolo II: «Santità, che ne è della causa di canonizzazione di monsignor Romero?».
La risposta è: «Sua Eccellenza monsignor Paglia mi ha inviato una biografia importante, che chiarisce molti punti della questione. Monsignor Romero è stato certamente un grande testimone della fede, un uomo di grande virtù cristiana, che si è impegnato per la pace e contro la dittatura e che è stato ucciso durante la celebrazione della Messa. Quindi una morte veramente “credibile”, di testimonianza della fede. C’era il problema che una parte politica voleva prenderlo per sé come bandiera, come figura emblematica, ingiustamente. Come mettere in luce nel modo giusto la sua figura, riparandola da questi tentativi di strumentalizzazione? Questo è il problema. Lo si sta esaminando ed io aspetto con fiducia quanto dirà al riguardo la Congregazione delle Cause dei Santi».
Sono trascorsi quasi 4 anni, la Congregazione, evidentemente, si affanna ancora a rimediare alla “strumentalizzazione”. Difficile pensare che trasmettere integra da strumentalizzazioni una storia così bruciante, una testimonianza resa nel cuore di una piccola Armagheddon, sia impresa possibile. Difficile pensare, anche, che valga la pena di tenere la lampada sotto il moggio per evitare che attiri odiose falene. Difficile ai burocrati convincersi che, dopo tutto, le strumentalizzazioni indichino anche nostalgia di verità, apprezzamento di grandezza. Non varrebbe la pena di rileggere il vangelo di Matteo al capo 13, versetti 28 e 29? Ai servi che vorrebbero raccogliere la zizzania appena spuntata, il padrone lo vieta: «No, perché raccogliendola non abbiate a sradicare insieme con essa anche il grano».
Credo che le lentezze del processo di canonizzazione di Romero debbano spingerci a meditare per l’ennesima volta alcuni problemi della vita della Chiesa. Il primo è quello del contrasto fra istituzione e profezia, tra abbandono al Dio che «ecco, fa nuove tutte le cose» e le strutture a servizio del cammino di una comunità non soltanto dinamica ma anche composita. Problema certamente di impossibile soluzione definitiva, ma che ogni generazione, ogni narrazione, ogni pontificato ed ogni ambito ecclesiale dovrebbero affrontare con la cura richiesta a chi cerca di essere fedele al suo Signore. Il “caso Romero” è uno dei tanti che sono stati consegnati a una profondissima sofferenza derivante da questa dialettica: da un lato il Vaticano, dall’altro la storia con le sue asprezze e le sue conquiste; da un lato chi custodisce ciò che è stato costruito, dall’altro chi accetta di camminare sotto cieli tempestosi e su incerti sentieri verso gli infiniti Golgotha della Terra e del Tempo. Da un lato chi difende l’intangibilità dell’ortodossia, dall’altro il pioniere che scopre il regno di Dio in regioni che sembravano deserte e prive di luci. E, infine, forse, si potrebbe dire: da un lato i filosofi, i canonisti, i sacerdoti nel Tempio e dall’altro chi accetta di ricevere dai poveri la teologia loro affidata dal Padre. Le comunicazioni fra questi due settori della Chiesa, il dialogo, l’ascolto, il reciproco riconoscimento sono gli unici strumenti che possono evitare – o almeno medicare – vicende che, come nel caso di Romero, sono di scandalo per chi si avvicina a una comunità che dovrebbe essere giudicata da come i suoi figli si amano l’un l’altro.
da Adista Documenti 24/11