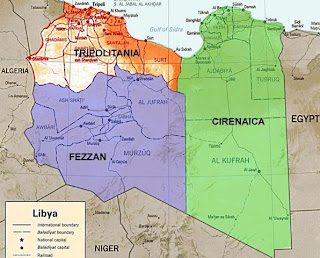martedì 27 settembre 2011
Il falso testamento

Testamento biologico Amare la vita senza crociate

di Pax Christi
Amore per la vita, relazione di cura e dignità umana: si tratta di temi di grande rilievo etico in quanto vanno a incidere nella relazione con il medico, con i parenti e non solo, in quelle situazioni delicatissime in cui il paziente non è in grado di manifestare una sua propria volontà per una grave invalidità come quando egli versa in uno stato vegetativo. Inoltre si tratta di casi relativamente nuovi in quanto sono stati resi possibili dai recenti e positivi successi della medicina che hanno consentito di strappare alla morte sempre nuove tipologie di ammalati. E paradossalmente numerosi tra i casi in questione sono in parte provocati dai progressi della scienza medica e dagli sviluppi della tecnica.
L’importanza etica di tali temi, unita alla loro novità, ha determinato un clima di contrapposizione che non ha favorito la ricerca delle soluzioni più ragionevoli e maggiormente orientate al bene comune. Così come è probabile che anche l’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica della legge sul fine vita in realtà sarà solo una prima tappa di un percorso che si annuncia controverso anche in considerazione del quadro costituzionale, giurisprudenziale e politico in cui si inserisce.
In questo contesto, ci sembra opportuno, come cristiani appartenenti a Pax Christi, di farci carico della condizione di incomprensione e di disagio determinatasi nella compagine ecclesiale e nella società civile a seguito delle modalità con cui si è giunti al voto in Parlamento. È importante che noi cristiani favoriamo un dibattito pubblico in cui sia ridotta la polemicità del confronto, siano mostrati i limiti di posizioni ideologiche (che potrebbero addirittura condurre alla diffusione di tesi dichiaratamente favorevoli all’eutanasia) e sia favorita la formazione di una convergenza di alto profilo attorno ai valori della persona, specialmente se malata, nella convinzione secondo cui «tutti gli uomini, credenti e non credenti, debbano contribuire alla retta edificazione di questo mondo, entro il quale si trovano a vivere insieme: il che non può avvenire senza un sincero e prudente dialogo» (Gaudium et spes, 21).
Anzitutto ci richiamiamo con forza all’imperativo che riassume tutti gli altri imperativi: l’amore che è dovuto al fratello specie quando è solo, debole, ammalato. Questo significa che la vita, la concreta vita di chi soffre, deve essere costantemente sostenuta, protetta, tutelata nella sua interezza. E la vita può essere criminosamente sottratta dall’eutanasia, ma può essere gravemente offesa anche nella situazione opposta dell’accanimento terapeutico in cui essa viene vanamente protratta attraverso – per usare le espressioni del Catechismo della Chiesa cattolica (n. 2278) – procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi. E va anche ribadito (più di quanto lo si sia fatto finora) che la vita è altresì minacciata nelle ancora più frequenti ipotesi di abbandono terapeutico in cui, per ragioni ultimamente economiche, al paziente non vengono offerte la cura e l’assistenza richieste. E l’abbandono terapeutico è la vera emergenza bioetica nei Paesi più poveri del nostro (cioè per la grande maggioranza della popolazione mondiale). Chi oggi difende l’attuale legge, esibendo l’intenzione di difendere il valore della vita, deve porsi con coerenza il problema di garantirne sempre le condizioni in vari contesti: nella cooperazione internazionale, oggi sollecitata a ridurre il dramma della fame nel Corno d’Africa; nella politica estera, dove l’intervento militare si arroga il diritto di scegliere quali vite difendere a scapito di altre; nell’economia nazionale, dove la manovra finanziaria colpisce pesantemente la vita di moltissime famiglie anche nell’ambito della sanità.
Da parte dei cristiani va poi affermato con chiarezza che l’amore verso chi soffre comporta una speciale attenzione alla considerazione della sua dignità di cui è parte essenziale il rispetto della sua ragionevole volontà in ordine all’avvio e prosecuzione delle terapie anche qualora egli non sia competente o capace. L’autodeterminazione del paziente (se intesa come arbitraria disposizione di sé) e il paternalismo del medico (se inteso come unilaterale decisione della terapia più adeguata) sono entrambe posizioni che non rendono conto di ciò che deve caratterizzare la relazione di cura. Il paziente deve potere essere certo che, senza complesse formalità, sarà rispettato nella sua volontà ragionevole anche qualora non potesse più confermarla personalmente. Il medico deve potere, fin che è possibile, dialogare con il suo assistito e quindi con le persone che gli sono vicine per attuare le terapie che egli giudica più opportune con la massima serenità anche sotto il profilo giuridico. In questa prospettiva, l’“alleanza terapeutica” di paziente e medico non deve essere solo un obiettivo programmatico, ma una pratica da realizzare anche nelle situazioni in cui il paziente può apparire come un soggetto passivo rispetto ad interventi altrui.
Aspettando le elezioni nel Deserto dei Tartari

ANCHE IERI si è ripetuto il logoro copione che si recita in Italia, da oltre un anno e forse più. Bersani ha invocato un governo di emergenza. Gli hanno fatto eco Fini e Casini, invocando nuove elezioni. Ma Berlusconi ha ribadito che non ha nessuna intenzione di dimettersi.
Né di anticipare il voto, senza la sfiducia del Parlamento. Anche se ormai la sua parabola è alla fine. O, forse, proprio per questo. Se uscisse di scena, a differenza del passato, stavolta difficilmente riuscirebbe a rientrare in gioco. Parallelamente, nel Pdl, pochi - oltre a Pisanu - sembrano disposti ad accantonare il proprio leader-padrone. A parte il fatto che nessuno ne avrebbe la forza, tutti si rendono conto che senza Berlusconi il Pdl resterebbe privo di identità e organizzazione. La stessa Lega vive con disagio crescente l'alleanza con Berlusconi. Soprattutto i militanti e la base, sempre più insofferenti. Ma Bossi e suoi fidi esitano a staccare la spina.
Il destino dei due leader è reciprocamente legato. Se Berlusconi cadesse, la posizione di Bossi verrebbe compromessa. Senza il Pdl e senza Berlusconi (per non dire senza Bossi), lontano dal governo: la stessa Lega, rischierebbe la marginalità politica e il declino elettorale. Come avvenne dopo la svolta secessionista del 1996. Una prospettiva insopportabile per un partito che ha da difendere (e da perdere) molti posti di governo - e di sottogoverno. Nella pubblica amministrazione e nella finanza. A livello nazionale e locale.
Così Berlusconi e il centrodestra "resistono" in Parlamento. Dove dispongono ancora di una maggioranza precaria. Sufficiente a garantire la "fiducia" quando è necessario. Mentre tra gli elettori oggi sono una minoranza, largamente "sfiduciata" dai cittadini.
Ciò rende il ricorso a elezioni anticipate assai improbabile. Anche se l'ipotesi echeggia, un giorno sì e l'altro pure. Ma le elezioni non le vuole nessuno. Anzitutto nella maggioranza. Figurarsi. Oggi, per il centrodestra, significherebbe perderle. Anche se Berlusconi dà il meglio di sé in campagna elettorale, quando è dato per spacciato. Ma stavolta è diverso. La sua stagione è finita. I valori e i modelli su cui ha fondato il proprio successo: logori e inattuali. La sua immagine non attrae più. Semmai avviene il contrario. La sua "base sociale" l'ha abbandonato. Gli imprenditori piccoli e grandi: ne chiedono le dimissioni da mesi. Ai loro congressi basta inveire contro il governo e il presidente del Consiglio per sollevare grandi boati di approvazione. La stessa Chiesa appare tiepida. Anche se le gerarchie mantengono un atteggiamento fin troppo prudente di fronte ai modelli e agli stili di vita proposti da chi guida il Paese.
Insomma, si tratta del momento peggiore per andare al voto, dal punto di vista di Berlusconi e del Pdl. Ma anche dal punto di vista della Lega, in evidente difficoltà nel recitare la parte dell'opposizione, dopo aver sostenuto fedelmente Berlusconi, da dieci anni in qua. Bossi lo ha detto esplicitamente a Pontida. È cambiato il "ciclo politico". A favore della Sinistra. E allora, perché votare? Tanto più che neppure a sinistra - nonostante il vento favorevole - si coglie molta voglia di andare al voto presto. Il Pd non si sente pronto. È diviso sulla questione delle alleanze. L'idea del Nuovo Ulivo, insieme all'Idv e a Sel, a Di Pietro e Vendola, dispiace a una parte del Pd, che preferirebbe la Grande Coalizione con il Terzo Polo. E teme di spingere l'Udc in braccio al centrodestra. A ragione, visto che le sorti della competizione elettorale diverrebbero altamente incerte.
Peraltro, la prospettiva del voto avvicinerebbe le primarie. Su cui nel Pd non c'è armonia di vedute. Quando e come farle? Primarie di partito o di coalizione? Oppure entrambe? Perché le primarie al gruppo del Pd piacciono quando l'esito è scontato. Non se sono davvero "aperte".
Infine, c'è la questione della "legge elettorale". Votare presto costringerebbe a utilizzare il famigerato Porcellum. Proprio mentre l'iniziativa referendaria, promossa da Parisi, volta ad abrogarlo e ristabilire il sistema elettorale precedente, ha ottenuto un massiccio sostegno popolare. Viaggia ben oltre le 500mila firme. Non a caso Alfano, a nome di Berlusconi, nei giorni scorsi, si è detto pronto a riformare l'attuale legge. Presumibilmente, per prendere tempo. E per evitare un nuovo referendum. Rischioso come il precedente, per il centrodestra. Mentre al Terzo Polo non piacciono né il Porcellum né il Mattarellum.
Mi rendo conto che questa ricostruzione, pedante e un po' prolissa, può apparire noiosa e scontata. Persino banale. Tuttavia, mi è parso utile proporla. Non solo a memoria futura - e presente. Ma perché dà il senso di quel che sta capitando nel nostro sistema politico. Mentre tutto intorno ci crolla addosso. Mentre le vicende politiche e i mercati globali richiederebbero - e, anzi richiedono - un governo che governi e un presidente del Consiglio credibile - o almeno non squalificato. Sostenuto da una maggioranza che sia tale non solo in Parlamento - e spesso neppure lì. Ma anche tra i cittadini e gli elettori.
In Italia, invece, viviamo un tempo di elezioni e dimissioni imminenti. Sempre possibili e da molte parti auspicate. Ma puntualmente scongiurate e rinviate. È come fossimo perennemente in crisi di governo. In campagna elettorale permanente. Quando non è possibile decidere nulla, perché è importante inseguire e conquistare ogni segmento di opinione pubblica. Ogni frammento del mercato elettorale. Un giorno dopo l'altro. Un momento dopo l'altro. Così tutto si agita, nel nostro piccolo mondo. Ma tutto resta uguale. Mentre fuori infuria la bufera (politica, monetaria, economica, finanziaria...).
Verrebbe da evocare la fortezza Bastiani, dove l'ufficiale Giovanni Drogo, insieme alla sua guarnigione, attende l'arrivo del nemico. Che non arriva mai. Nel Deserto dei Tartari narrato da Dino Buzzati. Ma si tratterebbe di una citazione troppo nobile, per il nostro povero Paese. Per il penoso spettacolo offerto dalla nostra scena politica. Che mi rammenta, piuttosto, un tapis roulant. Dove cammini e corri, con continui cambi di velocità e di pendenza. Ma resti sempre fermo. Nello stesso posto. Nella tua stanza. Senza una meta. Senza un orizzonte. Mentre il mondo fuori incombe.
La Repubblica (26 settembre 2011)
mercoledì 15 giugno 2011
Il popolo dei disobbedienti
di ILVO DIAMANTI
IL REFERENDUM è passato ma i suoi effetti - politici e sociali - dureranno a lungo. Perché il successo del referendum è, a sua volta, effetto di altri processi, maturati in ambito politico e sociale. E perché i referendum hanno sempre marcato le svolte della nostra storia repubblicana.
Fin dal 1946 - quando nasce, appunto, la Repubblica. Poi: nel 1974, il referendum sul divorzio. Il Sessantotto trasferito sul piano dei costumi. La svolta laica e antiautoritaria della società italiana. Nel 1991, giusto vent'anni fa, il referendum sulla preferenza unica per la Camera. È il muro di Berlino che rovina su di noi. Annuncia la fine della Prima Repubblica e l'avvio della Seconda. Nel 1995, il referendum contro la concentrazione delle reti tivù. Dunque, contro la posizione dominante di Berlusconi. Fallisce. E rende difficile, in seguito, ogni azione contro il conflitto di interessi. Da lì in poi tutti i referendum abrogativi falliscono. A partire da quello dell'aprile 1999. Riguardava l'abolizione della quota proporzionale nella legge elettorale. Non raggiunse il quorum per una manciata di votanti. Sancisce la fine del referendum come metodo di riforma e di cambiamento istituzionale, ad opera della società civile. Perché i referendum sono strumenti di democrazia diretta. Complementari, ma anche critici rispetto alla democrazia rappresentativa. Ai partiti e ai gruppi dirigenti che li guidano. Per questo hanno la capacità di modificare bruscamente il corso della storia. Quando il distacco fra la società civile e la politica diventa troppo largo. Negli ultimi vent'anni questo divario è stato colmato - in modo artefatto - dalla personalizzazione, dallo scambio diretto fra i leader e il popolo, attraverso i media. Ora questo ciclo pare finito. Il referendum di domenica scorsa lo ha detto in modo molto chiaro e diretto.
In attesa di vedere cosa cambierà - a mio avviso, molto presto - proviamo a capire cosa sia avvenuto e perché.
1. Il referendum, come avevamo già scritto, è il terzo turno di questa lunga e intensa stagione elettorale. Il suo esito è stato, quindi, favorito dai primi due turni. Le amministrative. Dal successo del centrosinistra a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari, Trieste. E dalla parallela sconfitta del Pdl e della Lega. Soprattutto, ma non solo, nel Nord. I referendum erano stati dissociati, temporalmente, dalle amministrative, per ostacolarne la riuscita. È avvenuto esattamente il contrario. Le amministrative hanno agito da moltiplicatore della mobilitazione e della partecipazione. Un effetto boomerang, per il governo, come ha rammentato Gad Lerner all'Infedele.
2. I singoli quesiti posti dai referendum, come di consueto, non sono stati valutati in modo specifico, dagli elettori. La differenza tra proprietà e uso dell'acqua, l'utilità della ricerca nucleare. In secondo piano. Al centro dell'attenzione dei cittadini, altre questioni, non di merito ma sostanziali. Il valore del bene comune. Il bene comune come valore. Ancora: la sicurezza intesa non come "paura dell'altro" ma come tutela dell'ambiente. La ricerca del futuro, per noi e per le generazioni più giovani.
3. Letti in questa chiave, i referendum sono divenuti l'occasione per fare emergere un cambiamento del clima d'opinione, ormai nell'aria - chi non ha il naso chiuso dal pregiudizio lo respirava da tempo. Una svolta mite, annunciata dal voto amministrativo, ribadita dal referendum. Una svolta di linguaggio, di vocabolario, che ha restituito dignità a parole fino a ieri dimenticate e impopolari. Vi ricordate altruismo e solidarietà? Chi aveva più il coraggio di pronunciarle? Per questo, paradossalmente, il referendum sul legittimo impedimento, il più politico, il più temuto dalla maggioranza e anzitutto dal suo capo, è passato quasi in second'ordine. A traino degli altri.
4. Qui c'è una chiave, forse "la" chiave del risultato. I referendum riflettono il cambiamento carsico, avvenuto e maturato nella società. Che, secondo Giuseppe De Rita, si sarebbe ulteriormente frammentata. In questa galassia, attraversata da emozioni più che da ragioni, dalle passioni più che dagli interessi, è cresciuto un movimento diffuso. Affollato di giovani e giovanissimi. La cui voce echeggia attraverso mille piccole manifestazioni, nei mille piccoli luoghi di vita quotidiana. Attraverso il contatto diretto. Attraverso la Rete. Per questo è poco visibile. Ma attivo e vitale. L'ostracismo della maggioranza di governo, il silenzio di MediaRai. Li hanno aiutati. Legittimati. Perché la tivù MediaRai e i suoi padroni, ormai, sono il passato.
5. Tuttavia, una partecipazione così alta sarebbe stata impensabile se non avesse coinvolto altri settori della società. Il popolo della Rete, per quanto ampio, è una èlite. Giovane, colta, cosmopolita. Non avrebbe sfondato se non avesse coinvolto genitori, nonni, zii. Un elettorato largo e politicamente trasversale. Il successo dei referendum, infatti, scaturisce dalla spinta dei movimenti sociali, dal sostegno dei partiti e degli elettori di centrosinistra. Ma anche da quelli di centrodestra. Si guardi la geografia elettorale della partecipazione. Le Regioni del Nord (ora non più) Padano hanno espresso i tassi di partecipazione fra i più elevati. Osserviamo, inoltre, il risultato complessivamente ottenuto alle Europee del 2009 dai partiti di Centrosinistra, Sinistra e dall'Udc. Quelli che hanno sostenuto l'opportunità di votare in questa occasione. Ebbene, risulta evidente che la partecipazione è stata molto più ampia rispetto alla loro base. Nel Nord Est: ha votato il 32% (e circa 1.700.00) di elettori in più. Nel Nord Ovest: il 29% (e circa 3.500.000) di elettori in più. In Italia, complessivamente, il 28% (e circa 13.000.000) di elettori in più. (Elaborazioni Demos, su dati Ministero degli Interno; indicazioni analoghe provengono dalle analisi dell'Istituto Cattaneo su dati delle elezioni politiche 2008).
6. Da qui il senso generale di questo passaggio elettorale. È cambiato il clima d'opinione. Il tempo della democrazia personale e mediale - come ha osservato ieri Ezio Mauro - forse è alla fine. Mentre si scorgono i segni di una democrazia di persone, luoghi, sentimenti. Passioni. I partiti e gli uomini che hanno guidato la stagione precedente, francamente, sembrano improvvisamente vecchi e fuori tempo. Il Pdl - ma anche la Lega. Berlusconi - ma anche Bossi. Riuscivano a parlare alla "pancia della gente", mentre la sinistra pretendeva di parlare alla "testa". Per questo il centrodestra era popolare. E la sinistra impopolare. Fino a ieri. Oggi, scopriamo che, oltre alla pancia e la testa, c'è anche il cuore. Parlare al cuore: è importante.
Fonte: La Repubblica (15 giugno 2011)
sabato 11 giugno 2011
LETTERA 150 marzo-giugno 2011

Rientrato nella capitale, l’uomo aveva completamente perso la voce per quindici giorni, poi la voce era tornata e se n’era andata la sensazione di debolezza che lo aveva afflitto. Si sentiva giovane e forte, dichiarò. Ma era felice, soprattutto perché gli era nata una nipotina “perfetta”, niente a che vedere con certi poveri piccoli mostri. Due mesi più tardi telefonai per avere sue notizie. “Il compagno ministro è morto – mi rispose un funzionario. -La nipotina? Non so niente di nipotine”.
Era una favela grande, nello splendore della Bahia. Arrivò un vecchio Prete-Manager italiano e decise che avrebbe beneficato i poveri, costruendo un ospedale; e costruendolo proprio lì, dove stava la favela. Tra il Vecchio e i favelados cominciò allora una guerra fatta di avvocati, carte bollate e polizia, da una parte, e, dall’altra, gli analfabeti e i loro bambini. Il primo round fu vinto dai testardi baraccati e allora qualcuno arruolò un gruppo di jaçungos per le necessarie pulizie. Gli jaçungos sono piccoli e grandi delinquenti, non costano neppure tanto e lavorano bene. Visitarono di notte la favela, spararono in alto, distrussero i piccoli orti, diedero qualche spallata alle baracche. I bambini piansero, gli uomini e le donne no. Gli imprenditori domandarono ai teppisti se fossero rincoglioniti, si dessero da fare. Allora gli jaçungos dinamitarono una fonte intorno alla quale la faavela era sorta - e la storia finì. Senza libera acqua i poveri non vivono. Il prete-manager diventò ancora più santo. (Interrogazione del deputato Masina al ministro degli esteri, X legislatura, 1989).
Simòn Perez Mocilla aveva sedici anni quando, nell’aprile del 2000, marciò verso Cochabamba, la terza città della Bolivia. con tutti gli abitanti del suo villaggio. Sulla strada nazionale, quando vi entrarono, c’era già una folla fittissima di campesinos e minatori di altri paesi; e c’erano le donne con i loro cappelli duri che i turisti italiani definiscono ridendo “bombette” e gli abiti verdi e rossi, e le bambine con grandi trecce nere, e i maschietti che cercavano di imparare le canzoni dei padri. Simòn e i suoi compagni gridavano: “L’acqua è nostra, l’acqua è nostra”: L’anno prima il governo aveva venduto la distribuzione dell’acqua a una multinazionale. Subito le tariffe erano state più che quadruplicate e poco dopo ancora quadruplicate. Persino per raccogliere l’acqua piovana ci voleva un permesso. Ogni famiglia doveva pagare per l’acqua almeno 2 dollari al giorno, cioè un quarto della spesa per il vitto. Gli ufficiali giudiziari correvano da una all’altra capanna per estorcere i balzelli. Inutilmente i vecchi avevano raccontato che l‘acqua era un dono della Pacha Mama, la grande Madre Terra. Quando il popolo boliviano decise che né acqua né aria potevano essere vendute, le multinazionali inferocirono: non soltanto quegli straccioni si permettevano di protestare, ma se avessero avuto successo avrebbero certamente finito per sostenere che anche il petrolio e il gas erano doni di quella loro genitrice del c… Allora i gringos misero sull’attenti i loro complici boliviani e questi inviarono la polizia con l’ordine di reprimere la protesta. Vi furono 6 morti e 175 feriti. Simòn fu ucciso mentre cercava di portare in salvo un bambino accecato dai lacrimogeni. Il governo si rimangiò l’accordo con la multinazionale.
Mentre la visagista gli rifaceva il tatuaggio sul cranio, la segretaria gli ricordò con qualche imbarazzo che il giorno dopo ci sarebbe stata “quell’udienza” in tribunale. Lui la guardò sorridendo, disse: “Mi consenta” e fece il gesto dell’ombrello.
Una constatazione (Centro Ricerca Pace, Viterbo)
Perdere i referendum, ovvero non raggiungere il quorum avrebbe conseguenze disastrose: la sconfitta rafforzerebbe enormemente le norme di legge che i referendum propongono di abrogare. In dettaglio: non raggiungere il quorum nel referendum per fermare il nucleare avrebbe come risultato un fortissimo sostegno alla follia nucleare; non raggiungere il quorum nei due referendum in difesa dell'acqua avrebbe come risultato un fortissimo sostegno alla mercificazione dell'acqua; non raggiungere il quorum nel referendum sul principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge avrebbe come risultato un fortissimo sostegno all'eversione dall'alto neofeudale.
Passaparola
Attenzione!
Le schede dei referendum sono di tipo "carta copiativa" ; se le sovrapponi, si segnano anche quelle sotto, che poi vengono annullate.
Il mio libro
Ettore Masina, L'ARCIVESCOVO DEVE MORIRE. Oscar Romero e il suo popolo. Ed. Il Margine, Trento
Pubblicato un libro, bisogna diffonderlo. Le coraggiose “piccole” editrici sono fortemente penalizzate da questo punto di vista perché non dispongono di un'apposita organizzazione, e, da parte loro, i librai sono per lo più impacciati dalla molteplicità della produzione e restii ad assumere impegni scarsamente retributivi. L'apparato pubblicitario impone, di fatto, autori e tendenze. Certi scrittori e certi libri rimangono ai margini del mercato editoriale, se i lettori non intervengono con le loro scelte consapevoli e solidali, facendosi essi stessi protagonisti di cultura, segnalando ad amici e librai le proprie positive esperienze. Da questo punto di vista è prezioso il tam tam dei lettori.
Per tutte queste ragioni e per l'interesse che porto al mio terzo libro su Romero (oltre a tutto, data la mia età, mi pare ovvio che sarà l'ultimo della mia, come dire?, produzione), ho ottenuto che la casa editrice pratichi ai miei amici lo sconto del 20% sul prezzo di copertina ´(18 €), il 22% se l’ordinazione è di 2 copie o più. La spedizione è gratis. Smisterò io stesso le richieste che mi arriveranno per e-mail. Indicate per favore l’indirizzo postale al quale volete ricevere il plico.
Dicono i lettori:
***La vicenda di Romero è penetrata fino alle radici dell’essere uomo e credente di Masina. Lui perciò ricrea il personaggio con l’autenticità e con la plasticità del grande artista. Raffaele Nogaro. ***Ritorna – riveduto e aggiornato con le ultime notizie sui retroscena del suo omicidio- il “classico” di Ettore Masina, uno dei libri più belli, intensi, emozionanti, sul vescovo Romero e sul suo popolo martoriato Gentes. *** Dobbiamo essere riconoscenti a Ettore Masina, al suo stile fluente, per averci comunicato un’immagine storica, spoglia di trionfalismi e profondamente evangelica, di questo santo del popolo, dei “dannati della terra. Leonardo Boff. ***Un’appassionata e lucida monografia. Gabriella Caramore, Uomini e Profeti. ***Ho appena terminato di leggere il libro. Esco sconvolto da questa lettura. Il libro mi ha tenuto col cuore in gola, anche se conoscevo benissimo il finale. E' un volume che consiglierò a tutti, magnifico. Gianluca Veltri. ***Sono una piccola sorella del Vangelo delle fraternita' di Charles de Foucauld., ho vissuto 24 anni di missione nel Salvador, terra "santa" di martiri. Ho apprezzato moltissimo il Suo libro, e puo' immaginare come mi abbia fatto rivivere la storia di questo mio popolo di adozione. Ci sarebbero tante cose di cui vorrei parlare con lei. Tanti nomi che Lei cita di gente conosciuta e amata... Ciò che piu' ho apprezzato e' la Sua maniera di coinvolgersi con la sofferenza della gente e l'amore verso Monsignor Romero. Grazie per questa grande testimonianza che dà nel libro; spero che siano in tanti a sentirla, apprezzarla e viverla come la vive Lei- piccola sorella Franca *** Ho appena finito di leggere L'Arcivescovo deve morire . Questo libro cosi fedele, che non giudica ma racconta, come se si fosse stati li' , ha il potere di far comprendere come l'Amore umile possa vincere su tutto. Barbara Villatora *** Grazie Ettore per le emozioni che hai saputo donarci ! Loris Nobili
giovedì 9 giugno 2011
Io vado a votare

ENERGIA
Ovunque l’uomo esplica la propria quotidiana attività c’è bisogno di energia. Tutto ciò che ci circonda ha bisogno di energia per funzionare, o quantomeno ne ha avuto bisogno per essere prodotto.
Per poter fornire l’energia vengono bruciate ingenti quantità di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturali), che provocano l’emissione in atmosfera di gas come il diossido di carbonio (CO2), che provoca l’effetto serra, una delle cause più importanti del cambiamento climatico.
L’elevata quantità di questi gas, alterando lo scambio di energia tra l’interno e l’esterno dell’atmosfera, provoca un mutamento degli equilibri climatici del nostro pianeta.
Più ancora, i combustibili fossili non solo ammorbano l’ambiente nel momento in cui vengono usati per produrre elettricità, ma occorre estrarre la materia prima, trasformarla, trasportarla e dopo averla usata nelle centrali, gestirne i residui (solidi, liquidi, gassosi).
Ad esempio, l’estrazione del petrolio (per i trasporti, il riscaldamento, la produzione di plastica, nylon, poliestere...) avviene quasi sempre in ambienti naturali come oceani, selve tropicali... e ciò implica inquinamento, deforestazione, espulsione di popolazioni indigene dal proprio habitat; il suo trasporto avviene attraverso oleodotti di migliaia di chilometri o grandi petroliere che, come si sa, spesso provocano incidenti drammatici (sversamenti in mare).
Ugualmente dicasi per il carbone, che si estrae in un luogo e si consuma in un altro, ed è perciò necessario trasportarlo, anche da un continente all’altro. Inoltre, la produzione di elettricità nelle centrali termiche è un processo altamente inquinante.
L’energia nucleare non è una soluzione
• Le centrali nucleari emettono nell’ambiente sostanze radioattive.
• Producono residui radioattivi che continueranno ad essere pericolosi per centinaia di migliaia di anni.
• Nei pressi delle centrali nucleari si è registrata una maggiore incidenza di tumori.
• Finora l’incidente di Chernobyl (Ucrania, 1986) ha causato 20.000 morti. Affrontiamo adesso la devastazione imprevedibile della catastrofe nucleare di Fukushima, Giappone, causata dal terremoto e dallo tsunami (marzo 2011).
• è una fonte di energia costosissima e può essere mantenuta solo con ingenti contributi statali.
• Il Protocollo di Kyoto non lo considera un freno per il cambiamento del clima.
Quali sono i passi da compiere
I passi per frenare il cambiamento del clima e cercare di ridurne i danni devono essere intrapresi sia a livello personale che a livello comunitario e sociale in 4 direzioni:
• Favorire le energie pulite e rinnovabili: il sole, il vento, l’acqua, i residui delle foreste, dell’agricoltura e dell’allevamento... in pochi decenni potrebbero fornirci tutta l’energia di cui abbiamo bisogno.
• Risparmiare energia evitandone l’inutile spreco.
• Utilizzarla in forma regionevole ed efficiente nelle città, negli edifici, nelle industrie, nei trasporti, in casa...
• Sostenere e collaborare con le associazioni e i gruppi che tutelano i tre punti precedenti.
Che cosa possiamo fare?
a) Illuminazione
• Uscendo da una stanza, ufficio o sala spegnere sempre la luce.
• Preferire, ove possibile, la luce naturale: se gli interruttori lo permettono, accendere solo le luci più distanti dalle finestre e avvicinare a queste i tavoli da lavoro.
• Usare lampadine a basso consumo energetico (fluorescenti compatte): durano quasi 10 volte in più e consumano il 75% in meno delle lampadine incandescenti. Le lampadine fluorescenti fanno risparmiare moltissimo nei locali in cui c’è bisogno di illuminazione continua e prolungata.
• Le lampade alogene (fari) sono adatte per l’illuminazione diretta di oggetti (quadri, opere d’arte) o punti strategici di un locale, ma non per l’illuminazione generale di una stanza.
• Negli ambienti in cui c’è bisogno della massima illuminazione, conviene sostituire gli interruttori normali con regolatori di intensità luminosa (Zimmer).
• Installare fotocellule nei corridoi, nei bagni e in altri locali pubblici.
• Pulire regolarmente i dispositivi di illuminazione e le lampadine: la polvere può ridurre del 20% il flusso di luce.
b) Riscaldamento e aria condizionata
• Mantenere il riscaldamento intorno ai 19–20 °C. Abbassando la temperatura di un solo grado si risparmia il 10% di energia!
• In caso di riscaldamento autonomo, installare apparecchi di regolazione della temperatura interna della casa. I termostati interrompono il funzionamento della caldaia quando la temperatura interna raggiunge quella programmata. Le valvole termostatiche, installate su ogni radiatore, permettono di differenziare la temperatura delle stanze: si può, ad esempio, riscaldare meno la cucina e le camere da letto e di più i bagni.
• Non ostacolare la circolazione di aria calda (non coprire i radiatori).
• Se si usano stanze o sale di riunione solo occasionalmente, terminato il lavoro, spegnere il riscaldamento.
• Far controllare la caldaia una volta l’anno: una caldaia in cattivo stato produce meno calore, consuma più combustibile e inquina di più.
• Evitare le perdite di calore: riparare le finestre che non si chiudono bene, abbassare le persiane di notte o quando si è fuori casa, coprire gli spifferi delle porte... meglio ancora sarebbe isolare la casa, installando isolanti nelle pareti e sotto i tetti, doppi vetri, finestre a chiusura ermetica.
• Il riscaldamento sotto il pavimento garantisce un risparmio energetico considerevole poiché utilizza acqua calda a una temperatura di 30-35 °C., molto inferiore a quella usata nei radiatori; la temperatura ridotta permette inoltre di collegare le caldaie ai panelli solari.
• In estate, regolare il condizionatore a non più di 8 °C meno della temperatura esterna e accenderlo solo quando necessario. Se aumentiamo di un grado la temperatura dell’aria condizionata, risparmiamo fino all’8% di energia!
• Non lasciare acceso il condizionatore se la stanza rimane inutilizzata a lungo o quando si apre la finestra per arieggiare.
• Pulire con frequenza i filtri del condizionatore.
c) Strumenti di lavoro
• Comperare apparecchi informatici ed elettrici a basso consumo energetico: i prodotti conformi a precise disposizioni in materia di risparmio energetico, sicurezza e ambiente sono contraddistinti da un’etichetta che ne certifica la qualità (generalmente un’etichetta Energy Star o Ecolabel)
• Programmare il computer e lo schermo in modo che vadano in standby se non sono usati per un dato lasso di tempo. Evitare in ogni caso di lasciarli in standby per un lungo periodo: anche questa funzione consuma energia (la TV spenta con il telecomando resta in stand-by ed il 10% del consumo energetico delle nostre case è dovuto agli apparecchi lasciati in stand-by).
• Spegnere l’interruttore principale e togliere la presa di corrente al termine della giornata:
i trasformatori degli apparati informatici ed elettrici consumano energia anche quando sono spenti.
• Accendere la fotocopiatrice e la stampante solo quando è necessario.
• Se si devono salire solo 2 o 3 piani, servirsi delle scale evitando, se possibile, l’ascensore.
Un po’ di esercizio fisico migliora la salute e contribuisce ad un risparmio di quasi 30 Wh per ogni viaggio evitato.
d) Elettrodomestici
• Ridurre l’uso di piccoli elettrodomestici non indispensabili, ad esempio lo spremiagrumi...
• Controllare l’etichetta energetica degli elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie...) prima di comprarli; acquistare prodotti di CLASSE A (etichetta verde). Un prodotto Classe A consuma quasi il 30% in meno di energia e inquina meno.
• Usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico con programmi a bassa temperatura.
• Porre il frigorifero e il congelatore lontani da fonti di calore (radiatori e finestre)
• Regolare il termostato del frigorifero e del congelatore a temperatura media: temperature troppo basse non servono per la conservazione degli alimenti.
• Non mettere alimenti caldi nel frigorifero o nel congelatore (provocano la formazione di ghiaccio)
• Togliere regolarmente il ghiaccio dalle pareti del freezer: uno strato di ghiaccio superiore a 5 mm è isolante e determina un aumento del consumo energetico dell’apparecchio.
• Ridurre il preriscaldamento del forno.
• Regolare la caldaia del bagno a una temperatura media, non superiore ai 55 °C.
• Installare la caldaia del bagno vicino al luogo di utilizzo dell’acqua calda per evitare dispersioni di calore attraverso le tubature.
• Evitare di tenere il televisore e altri apparecchi elettronici (modem, masterizzatore) in standby; se non si usano per lungo tempo, spegnerli del tutto.
domenica 8 maggio 2011
Vendetta è stata fatta, non giustizia - Una pagina da meditare
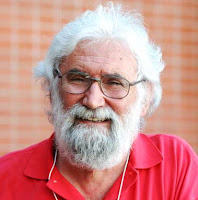
Leonardo Boff - Filosofo-Teologo
Bisognerebbe essere nemici di se stessi e contrari ai valori umanitari minimi per approvare il nefasto crimine del terrorismo di Al Qaeda dell’11 settembre del 2001 a New York. Ma è a qualsiasi titolo inaccettabile che uno Stato, quello militarmente più potente il mondo, per rispondere al terrorismo sia diventato esso stesso uno Stato terrorista. È quello che ha fatto Bush, limitando la democrazia, sospendendo la validità assoluta di alcuni diritti, erano appannaggio del paese. Più ancora, scatenò due guerre, contro l’Afghanistan e contro l’Iran, dove ha devastato una delle più antiche culture dell’umanità con 100.000 morti e più di 1 milione di sfollati.
A questo punto è necessario rinnovare la domanda che ha quasi nessuno interessa porre: Perché si sono verificati tali atti terroristici? Il vescovo Robert Bowman de Melbourne Beach da Flórida, che precedentemente era stato pilota di caccia militare durante la guerra del Vietnam ha risposto chiaramente, sul National Catholic Reporter, in una lettera aperta e inviata al presidente: “Siamo bersaglio dei terroristi perché, in gran parte del mondo, il nostro governo difende la dittatura, la schiavitù e lo sfruttamento umano. Siamo bersaglio dei terroristi perché ci odiano e ci odiano perché il nostro governo fa delle cose odiose”.
Non ha detto una cosa diversa Richard Clarke, responsabile, contro il terrorismo, della Casa Bianca in un’intervista a Jorge Puntual, trasmessa dalla Globonews il 28/02/2010 e ripetuta il giorno 3 maggio 2011. Aveva avvertito la C.I.A. e il presidente che un attacco di al Qaeda era imminente a New York. Non gli dettero ascolto. Subito dopo avvenne, e questo lo ha riempito di rabbia. Questa rabbia è aumentata contro il governo quando ha visto che con bugie e falsità Bush, per pura volontà imperiale di mantenere l’egemonia mondiale, decretò una guerra contro l’Irak che non aveva nessuna relazione con l’11 settembre. La rabbia arrivò al punto che per motivi di salute e di decenza si dimise dalla carica.
Più impressionante è stato Chalmers Johnson, uno dei principali analisti della C.I.A. pure in una intervista allo stesso giornalista il giorno 2 maggio di quest’anno su Globonews. Ha conosciuto dal di dentro le malefatte che Le oltre 800 basi militari nordamericane, sparse per il mondo intero, perché suscitano rabbia e rivolta nelle popolazioni, brodo di coltura per il terrorismo. Cita il libro di Edoardo Galeano “Le vene aperte dell’America Latina” per illustrare le barbarità che gli organi dell’intellighenzia nordamericani hanno compiuto da queste parti. Denuncia il carattere imperiale dei governi, fondato sull’uso della intellighenzia che raccomanda colpi di Stato, organizza assassinii di leaders e insegna a torturare. Per protesta, si mise e andò a fare il professore di storia all’Università della California. Ha scritto tre tomi “Blowback”, “Rappresaglia” dove prevedeva, con alcuni mesi di antecedenza le rappresaglie contro la prepotenza nordamericana nel mondo. Fu ritenuto come profeta dell’11 settembre. Questo è lo sfondo per intendere l’attuale situazione culminata a con l’esecuzione criminale di Osama Bin Laden.
Gli organi dell’intellighenzia nordamericani sono una manica di falliti. Per 10 anni hanno rastrellato il mondo a caccia di Bin Laden. Non ci sono riusciti. Soltanto usando un metodo immorale, la tortura di un messaggero di Bin Laden, sono riusciti ad arrivare al suo nascondiglio. Pertanto, non hanno avuto nessun merito loro esclusivo.
Tutto in questa caccia sta sotto il segno dell’immoralità, della vergogna e del crimine.
Innanzi tutto, il presidente Barak Obama, come se fosse un “dio” ha ordinato l’esecuzione/omicidio di Bin Laden. Questo è contrario al principio etico universale “Non ucciderai” e degli accordi internazionali che prescrivono la prigione, il giudizio e la punizione dell’accusato. Così è stato fatto con Hussein in Irak, con i criminali nazisti a Norinberga, con Eichman in Israele e con altri accusati. Con Bin Laden si è preferita l’esecuzione intenzionale, crimine per il quale Barak Obama dovrà un giorno rispondere. In seguito, si è sequestrato il cadavere e lo hanno buttato in mare, crimine contro la pietà familiare, diritto che ogni famiglia ha di seppellire i propri morti, criminali o no, dato che per cattivi che siano, sono sempre esseri umani.
Non è stata fatta giustizia. È stata fatta una vendetta, sempre da condannare. “Mia è la vendetta” dice il Signore delle scritture delle tre religioni abramiche. Adesso staremo sotto il potere di un imperatore sul quale pesa l’accusa di assassinio. E la necrofilia delle moltitudini ci sminuisce e copre di vergogna tutti noi.
Leonardo Boff e autore di “Fondamentalismo, terrorismo, religione e pace”, Vozes 2009.
lunedì 21 marzo 2011
Santo? Non subito
di Ettore Masina
Sono trascorsi trent’anni dal martirio di Monseñor. Il popolo salvadoregno è rimasto fra i più miseri della Terra, l’80% della sua popolazione vive sotto il livello della povertà, la disoccupazione è altissima, le potenzialità turistiche della sua economia (El Salvador è un paese meraviglioso di vulcani e di laghi, di spiagge, di buon clima) sono bloccate dal proliferare del narcotraffico e di una criminalità giovanile organizzata per bande (le maras), alimentata dalla miseria: 4 mila 365 morti nel 2009. Il fenomeno è così grave che negli ultimi tempi in certi ambienti della polizia e dell’esercito sono riemersi nuclei di squadroni della morte che pretenderebbero di risolvere il problema con le armi. Adesso, tuttavia, il governo è ben lontano dall’accettare una politica del terrore. El Salvador, infatti, è finalmente una democrazia, schiacciata dalle terribili eredità della guerra civile (e naturalmente dalla crisi economica mondiale), ma guidata da persone oneste e desiderose di costruire strade di giustizia. Nelle elezioni del marzo 2009 la destra è stata sconfitta ed è stato eletto presidente il candidato del FLMN, trasformato in partito: Mauricio Funes, 51 anni, giornalista, con una faccia rotonda e paciosa, un uomo intelligente e coraggioso, anche lui marchiato dalla tragedia della guerra civile perché un suo fratello è stato ucciso dai militari. Prima della cerimonia del suo insediamento, Funes è sceso nella cripta della cattedrale di San Salvador in cui è sepolto l’Arcivescovo, per rendere omaggio alla sua memoria. Poi il nuovo presidente è andato all’aeroporto internazionale; davanti a un grande “murale” in cui Oscar Romero è raffigurato in mezzo a un gruppo di bambini, Funes, a nome dello Stato, ha chiesto perdono per il suo assassinio (…).
Così Oscar Romero continua a essere una guida per il suo popolo, anche se dopo la morte di lui il popolo salvadoregno si è demograficamente “rinnovato”: ben più di metà degli abitanti è nata dopo quel terribile marzo 1980, mentre sono morti almeno 400 mila dei salvadoregni che lo acclamarono santo.
Tuttavia non si può parlare di questo piccolo grande vescovo come di un personaggio soltanto salvadoregno e neppure soltanto cattolico. Molte Chiese (da quella luterana a quella vetero-cattolica) celebrano ogni anno il suo sacrificio; nel 1998 la regina Elisabetta ha presenziato alla cerimonia con la quale gli anglicani gli hanno eretto una statua sulla porta occidentale di Westminster, accanto alle immagini di altri nove “martiri del Novecento”: Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Massimiliano Kolbe... Un'altra effige di lui è stata posta nella National Cathedral (episcopaliana) a Washington. Si calcola che siano almeno un milione le case dell’America del Nord in cui si trova la riproduzione di un ritratto dell'arcivescovo, opera del pittore Robert Lentz, un frate francescano americano (...).
A chiedere perché mai il martire non sia stato ancora proclamato santo è certamente una immensa folla di credenti: ma attendono una risposta a questo inquietante interrogativo anche molti e molte che pure non si definirebbero cristiani, uomini e donne i quali pensano che la violazione e la difesa dei diritti umani segnano, profondamente, la nostra civiltà; e si domandano perché la Chiesa cattolica non si mostri orgogliosa di questo suo figlio. (…).
I vescovi latino-americani riuniti a Roma nel Sinodo del 1997 hanno chiesto che la causa del loro confratello venisse rapidamente istruita. Sono passati tredici anni, risposte: nessuna. Nel trentesimo anniversario dell’uccisione, i vescovi del Salvador hanno ripetuto la richiesta. Scrivo queste righe nel febbraio dell’anno 2011. Sino ad oggi, risposte: nessuna. (...). Durante il suo pontificato Giovanni Paolo II ha proclamato più di milleottocento tra santi e beati. Ma Romero, no. (…).
ABBIAMO BISOGNO DI “SANTI VIVI”
Certamente il caso di Oscar Romero è del tutto singolare. Egli fu assassinato mentre celebrava una messa, e perciò i suoi fedeli lo definirono martire. Tuttavia, secondo qualche “esperto”, per essere considerato tale gli manca un requisito: quello di essere stato ucciso in odium fidei, da qualcuno che odiava la fede cattolica. Odio ci fu, dicono i sostenitori di questa tesi, ma politico: i mandanti dell’assassinio e probabilmente lo stesso carnefice credevano di essere buoni cattolici e di avere compiuto il loro delitto per il bene della Chiesa, che Romero e il suo popolo inquinavano con il loro “comunismo”. Del resto quasi tutti gli altri vescovi salvadoregni (tutti, tranne il successore di Romero, Rivera y Damas) condividevano, più o meno consciamente, questo giudizio. Un collaboratore - e amico - dell’Arcivescovo mi ha raccontato che nel secondo viaggio di Wojtyla a San Salvador (1996), Giovanni Paolo II domandò ai vescovi che pranzavano con lui nella sede della Nunziatura cosa pensassero di una canonizzazione di Romero: «Subito monsignor Revelo disse che sarebbe stato un grande errore, Romero era il responsabile dei 70 mila morti della guerra civile. La brutalità di questa affermazione non piacque al papa, che tolse bruscamente la parola a Revelo. Ma anche altri parlarono contro Romero. Il pontefice si mostrò irritato e cambiò discorso… Pensai allora - concluse il mio interlocutore - che la canonizzazione dell’arcivescovo non sarebbe avanzata sino a che quei vescovi antagonisti non fossero morti». Da allora, tutti questi alti ecclesiastici si sono spenti. Ultimo, monsignor Revelo, nell’anno 2000. Il Vaticano ha continuato a tacere.
La questione del martirio, comunque, sembra risolta perché proprio Giovanni Paolo II l’aveva superata già nel 1982, proclamando la santità di Maximilian Kolbe, il francescano polacco che, nel lager di Auschwitz, salvò la vita di un padre di famiglia condannato a morire nel bunker della fame, sostituendolo. Wojtyla parlò allora di «martire della carità». (…). E fu proprio Giovanni Paolo II, in una cerimonia giubilare al Colosseo, il 7 maggio dell'anno 2000 a catalogare l'arcivescovo di San Salvador fra «i nuovi martiri» (...).
Questo riconoscimento fu espresso dieci anni fa: evidentemente alla Congregazione dei Santi neppure la parola di Giovanni Paolo II è bastata.
Molti vescovi, del resto, hanno applicato e applicano oggi la definizione di martire all’arcivescovo di San Salvador, per esempio il cardinale Martini, che ha detto: «Romero è stato un martire della giustizia, della verità e della carità». (…).
Per chi non è cattolico o non crede nella necessità dell’intermediazione dei santi, la questione della canonizzazione rimane pur sempre importantissima da un punto di vista “generativo”: risiede nella possibilità della Chiesa di proporre modelli di comportamento particolarmente vicini alla radicalità evangelica.
Ho raccontato di non avere potuto andare a pregare sulla tomba di Romero, all’epoca del mio viaggio (gennaio-febbraio 1992), perché la cattedrale era chiusa per lavori in corso. Vero, ma poi ho saputo che c’era anche un’altra ragione: su richiesta della nunziatura, i lavori, pur necessari, offrivano la possibilità di bloccare quello che veniva definito un culto pubblico di Monsignore, cioè la pratica affermazione della sua santità da parte di gruppi di fedeli. Che la Chiesa cerchi di impedire il più che possibile diffondersi di superstizioni, nella devozione a “santi” che in realtà furono soltanto degli invasati o degli imbroglioni, questo è ovviamente legittimo e spesso provvidenziale. Però a me sembra anche di grande importanza quanto è scritto in un documento salvadoregno: «(…) Crediamo che non basti appellarsi alle norme dei processi di canonizzazione che vietano un culto pubblico. In primo luogo, è difficile, se non impossibile, che la gente comprenda il concetto e le sue finalità. Ma, più profondamente, bisogna riconoscere che (...) se il “fenomeno Romero” è autentico, è inutile tentare di “privatizzare” il suo ricordo (...). E se Monsignore è necessario (...), non è cosa buona provvedere a tenerlo muto per alcuni anni, fino a quando sia canonizzato, perché è adesso, in questi anni, che abbiamo bisogno della sua ispirazione e del suo coraggio. Non abbiamo bisogno di santi “morti”, canonizzati quando nessuno li conosce e la loro parola non è più attuale, abbiamo bisogno di santi “vivi” che animino i cristiani qui e ora...». (…).
EFFETTI COLLATERALI
Romero ha tempestato il Vaticano di messaggi e di dossier. Perché nessuno ha saputo leggerne la terribilità della situazione del Salvador e dell’Arcivescovo? Quali informazioni (e date da chi) giungevano da San Salvador? E che cosa veniva “passata” al pontefice da chi era incaricato di riassumergli la documentazione? Gli incontri fra Romero e il suo papa sono segnati da ombre che si interpongono fra i due.
Certamente la guerra fredda ne aumenta il gelo.
La situazione della Chiesa nei paesi dell’Est, in seguito agli accordi di Yalta, era stata per anni segnata dalla ottusa brutalità del comunismo sovietico. Giovanni XXIII e Paolo VI avevano avviato con quei regimi un cauto (o cautissimo) dialogo. Quando fu eletto il papa polacco, nell’ottobre del 1978, l’impero sovietico cominciava a scricchiolare, e l’accorta politica “della pazienza”, portata avanti dal cardinale Casaroli, dava i primi frutti, ma la libertà religiosa in quegli Stati era ancora una meta lontana (...). Fu ben presto chiaro che la sofferta esperienza di tanti anni di confronto con il comunismo avevano maturato in Karol Wojtyla due convinzioni. La prima, che l’unità dei vescovi di una nazione era un valore assoluto, l’unica garanzia per la libertà della Chiesa. La seconda (che egli attenuò in seguito, dopo il 1989), era la seguente: che mentre le dittature comuniste miravano ad essere definitive e radicalmente anticristiane (perciò il Nemico per antonomasia), le dittature “di destra” (militari e no) potevano essere considerate provvisorie, forme di governo richieste in periodi difficili della storia. (…).
Le dittature installate in quegli anni nell’intero continente esibivano un cerimonioso rispetto per la Chiesa cattolica e un’attenta cura alla conservazione dei suoi privilegi. Erano sostenute - o, come nel caso del Salvador, dirette - da quei grandi ricchi che le gerarchie locali e il Vaticano avevano considerato per secoli benefattori e difensori. Quei regimi colpivano gli oppositori con grande violenza (istituzionale o affidata a polizie segrete, a formazioni paramilitari) - e fra questi oppositori v’erano anche non pochi cattolici e perfino sacerdoti - ma i nunzi pontifici, i quali mantenevano generalmente ottimi rapporti con i governanti, garantivano al Santo Padre che certi tristissimi episodi erano, per così dire, le inevitabili scorie di un disegno politico inteso a difendere i valori della cultura cristiana dalla minaccia comunista. Anche la diplomazia degli USA denunziava il non allineamento o addirittura l’ostilità di movimenti cattolici nei confronti della sua influenza economica e politica. Nella sua enciclica Populorum progressio, del resto, papa Montini aveva (26 marzo 1967) condannato «l’imperialismo internazionale del danaro» e ammesso, in casi estremi di tirannia, la liceità di una rivoluzione popolare.
ROMERO È NOSTRO
I vescovi cattolici che presiedono diocesi sono più di 2 mila 700. Il nuovo papa deve imparare a conoscerli tutti, loro e i loro problemi. Romero è per Wojtyla un ignoto. L’Arcivescovo non ha partecipato al Concilio, che è stato un momento in cui molti “padri” hanno imparato a conoscersi e fra loro sono nate amicizie e solidarietà. È la Curia vaticana a fornirne un identikit. Certamente non può riuscire gradito al nuovo papa un presule che rompe l’unità episcopale del suo paese e che si permette, scavalcando ogni vertice vaticano, di scrivere, a nome proprio, al presidente degli Stati Uniti. Fra l’elezione di Giovanni Paolo II e l’assassinio di Romero corrono un anno e 5 mesi, un tempo troppo breve perché nasca un rapporto di mutua comprensione fra due pastori che devono annunziare il vangelo in un mondo stravolto da drammatiche tensioni. Si può forse comprendere perciò che il papa veda nel delitto di San Salvador soprattutto un attacco alla Chiesa, alla dignità episcopale e un grave sacrilegio. In un’intervista rilasciata a Mario Ponzi, il cardinale Roberto Tucci s.j., organizzatore dei viaggi di Giovanni Paolo II, racconta quanto avvenne nel 1993 a San Salvador: «Papa Wojtyla nell'affrontare situazioni difficili, a volte anche scabrose o pericolose, era testardo. Come dimenticare la sua determinazione nel voler pregare a tutti i costi sulla tomba dell'arcivescovo Oscar Arnulfo Romero a San Salvador? Ignorare quella tomba era stata una delle condizioni poste dal Governo per acconsentire alla visita. I vescovi sconsigliarono il Papa di andare. Non ci fu nulla da fare: Giovanni Paolo II voleva farlo perché si trattava di un vescovo ucciso mentre celebrava l'Eucaristia. Quando arrivammo sul posto, trovammo la cattedrale sprangata. Il Pontefice si impuntò e disse che non si sarebbe mosso di lì fino a che non gli fosse stato consentito di pregare su quella tomba. (…)».
Secondo alcuni testimoni, ponendo le mani sulla tomba, Giovanni Paolo II esclama: «Romero è nostro». L’importanza attribuita dal papa a questa cerimonia contrasta evidentemente con la sobrietà della definizione che egli dà di Romero: «Zelante pastore». È una definizione che Wojtyla manterrà in tutte le occasioni, anche quando accetta di inserire il nome dell’arcivescovo nell’elenco dei martiri del nostro tempo. La canonizzazione di Monsignore non è certo una priorità nell’agenda del nuovo papa. La Curia ne tiene conto. Il pontificato di Giovanni Paolo II dura 27 anni.
LA LAMPADA SOTTO IL MOGGIO
C’è un’accusa che la curia vaticana rivolge a Romero come ad altri vescovi dell’America Latina, ed è quella di essere un sostenitore della Teologia della Liberazione che va diffondendosi alla fine degli anni ‘70. Si potrebbe definirla una teologia continentale, nel senso che tenta di elaborare un’espressione della fede distaccata dalla tradizione europea (e vaticana!) e più aderente alla specificità del luogo e della sua storia. «Individua nel povero come soggetto storico il locus theologicus di una riflessione che vede nella fine della schiavitù narrata dall’Esodo e nella marginalità oppressa di Gesù di Nazareth una lente con cui interpretare il destino storico e spirituale delle masse diseredate (…). Per papa Wojtyla l’adozione dell’analisi e del vocabolario marxista che viene compiuta (con accentuazione diversa) dai teologi (…) è inquietante (…). Per lui ogni evocazione del pensiero marxiano inquina il desiderio di giustizia, corrompe l’immagine del povero riducendola all’ideologia di classe e alla fine diventa un cedimento alla propaganda comunista» .
Che c’entra Romero? Il fatto è che uno dei centri di elaborazione della Teologia della Liberazione è a San Salvador, in quella UCA dove, nel 1986, si è compiuta la strage dei gesuiti, ai quali l’Arcivescovo era legato da amicizia e collaborazione. Gli uomini di punta di quel gruppo erano Ignacio Ellacuria e Jon Sobrino. Ellacuria è stato bestialmente massacrato, Sobrino, invece, in quel periodo era all’estero e si è salvato. Salvo, ha continuato la sua ricerca teologica ma ha anche deciso di lavorare per la canonizzazione di Romero. È facile capire che con un “procuratore” del genere, più volte ammonito dal cardinale Ratzinger cui Giovanni Paolo aveva affidato l’ex Sant’Offizio, a Roma la “causa” dell’Arcivescovo abbia dovuto superare intoppi. Il 20 marzo 2004 l’arcivescovo di San Salvador Fernando Sáenz Lacalle ha annunciato in una conferenza stampa che il processo di beatificazione, avviato nel 1994, «è ancora in una fase iniziale, poiché, da quanto ho capito, il caso non è passato alla Congregazione per la Causa dei Santi: si trova ancora alla Congregazione per la Dottrina della Fede». (…).
In viaggio per il Brasile, il 9 maggio 2007, i giornalisti pongono a Benedetto XVI la domanda che tante volte avevano posto a Giovanni Paolo II: «Santità, che ne è della causa di canonizzazione di monsignor Romero?».
La risposta è: «Sua Eccellenza monsignor Paglia mi ha inviato una biografia importante, che chiarisce molti punti della questione. Monsignor Romero è stato certamente un grande testimone della fede, un uomo di grande virtù cristiana, che si è impegnato per la pace e contro la dittatura e che è stato ucciso durante la celebrazione della Messa. Quindi una morte veramente “credibile”, di testimonianza della fede. C’era il problema che una parte politica voleva prenderlo per sé come bandiera, come figura emblematica, ingiustamente. Come mettere in luce nel modo giusto la sua figura, riparandola da questi tentativi di strumentalizzazione? Questo è il problema. Lo si sta esaminando ed io aspetto con fiducia quanto dirà al riguardo la Congregazione delle Cause dei Santi».
Sono trascorsi quasi 4 anni, la Congregazione, evidentemente, si affanna ancora a rimediare alla “strumentalizzazione”. Difficile pensare che trasmettere integra da strumentalizzazioni una storia così bruciante, una testimonianza resa nel cuore di una piccola Armagheddon, sia impresa possibile. Difficile pensare, anche, che valga la pena di tenere la lampada sotto il moggio per evitare che attiri odiose falene. Difficile ai burocrati convincersi che, dopo tutto, le strumentalizzazioni indichino anche nostalgia di verità, apprezzamento di grandezza. Non varrebbe la pena di rileggere il vangelo di Matteo al capo 13, versetti 28 e 29? Ai servi che vorrebbero raccogliere la zizzania appena spuntata, il padrone lo vieta: «No, perché raccogliendola non abbiate a sradicare insieme con essa anche il grano».
Credo che le lentezze del processo di canonizzazione di Romero debbano spingerci a meditare per l’ennesima volta alcuni problemi della vita della Chiesa. Il primo è quello del contrasto fra istituzione e profezia, tra abbandono al Dio che «ecco, fa nuove tutte le cose» e le strutture a servizio del cammino di una comunità non soltanto dinamica ma anche composita. Problema certamente di impossibile soluzione definitiva, ma che ogni generazione, ogni narrazione, ogni pontificato ed ogni ambito ecclesiale dovrebbero affrontare con la cura richiesta a chi cerca di essere fedele al suo Signore. Il “caso Romero” è uno dei tanti che sono stati consegnati a una profondissima sofferenza derivante da questa dialettica: da un lato il Vaticano, dall’altro la storia con le sue asprezze e le sue conquiste; da un lato chi custodisce ciò che è stato costruito, dall’altro chi accetta di camminare sotto cieli tempestosi e su incerti sentieri verso gli infiniti Golgotha della Terra e del Tempo. Da un lato chi difende l’intangibilità dell’ortodossia, dall’altro il pioniere che scopre il regno di Dio in regioni che sembravano deserte e prive di luci. E, infine, forse, si potrebbe dire: da un lato i filosofi, i canonisti, i sacerdoti nel Tempio e dall’altro chi accetta di ricevere dai poveri la teologia loro affidata dal Padre. Le comunicazioni fra questi due settori della Chiesa, il dialogo, l’ascolto, il reciproco riconoscimento sono gli unici strumenti che possono evitare – o almeno medicare – vicende che, come nel caso di Romero, sono di scandalo per chi si avvicina a una comunità che dovrebbe essere giudicata da come i suoi figli si amano l’un l’altro.
da Adista Documenti 24/11
mercoledì 16 marzo 2011
lunedì 14 marzo 2011
Lettera aperta di mons. Bettazzi al vescovo Negri sull’indignazione dei cattolici

Roma, 6 marzo 2011 – Venerato Confratello, mi è stato segnalato l’articolo che Lei ha inviato al settimanale “Tempi”, confermato da un’intervista a La Stampa. Questo ha stimolato la mia antica abitudine di scrivere “lettere aperte”; avevo già respinto la tentazione di farlo con i nostri Superiori, non ritenendolo corretto, mi permetto di farlo ora con Lei, Vescovo autorevole, ma sempre a livello di responsabili – anche se io sono emerito – di diocesi comuni.
Perché, per quanto giro in Italia, sento spesso la lamentela dei cristiani di fronte alla mancanza di “indignazione” – che Lei dice non essere “atteggiamento cattolico” – di noi vescovi di fronte al malcostume della politica, e non solo per gli scandali “privati”, ma anche per la moda invalsa di leggi ad personam, proposte – si dice – per difendersi da una Magistratura che esorbita dalla sue funzioni (Lei lo dice “muoversi con prepotenza”), ma che in realtà non fa che assicurare che la legge sia uguale per tutti. Anche se non poche di queste accuse vengono dimostrate serie e verosimili, dal fatto che si pensa non di difendersi da esse, ma di scavalcarle con leggi specifiche e con ben calcolate prescrizioni. Quanto all’indignazione, anche Gesù più di una volta si è indignato, e proprio contro chi utilizza la posizione pubblica a difesa dei propri interessi personali o di casta.
Ella rivendica, nella espressa difesa del Governo e del suo Presidente, l’appoggio che essi danno ai “principi non negoziabili”, quali la difesa della vita al suo inizio e al suo termine o della famiglia naturale: e questo giustificherebbe il sostegno, senza indignazione, ad un Governo che si mostra invece insensibile di fronte a quello che è il fondamentale “principio non negoziabile”, che è la solidarietà; perché se questa si esprime davanti alle vite più deboli, come sono appunto quella iniziale e quella terminale, ma, per essere convincente, deve impegnarsi anche contro tutte le vite minacciate, come sono quelle di quanti sfuggono la miseria insopportabile o la persecuzione politica, che sono invece fortemente condizionate dal nostro Governo (quante vite umane sono sparite nel nostro mare o per le imposture della Libia!). Anche per le consonanze cristiane non si è fatto nulla per favorire la vita nascente con leggi che incoraggino il matrimonio e la procreazione, come ha fatto la “laica” Francia.
Ella ribadisce che, dei politici, andrebbe valutato solo il comportamento pubblico (appunto, così contrastante dunque con il primo principio “non negoziabile”, quello della solidarietà) e non quello privato, pur così poco favorevole sia alla famiglia che alla vita nascente; ma già gli antichi ammonivano che “noblesse oblige”, cioè che chi sta in alto deve dare il buon esempio, perché esso – tanto più in quest’era mediatica – influisce sull’opinione pubblica. Ed è questo che dovrebbe preoccupare noi vescovi, cioè il diffondersi, soprattutto nei giovani, dell’opinione che quello che conta è “fare i furbi”, è riuscire in ogni modo a conquistare e difendere il proprio interesse, il bene particolare, anche a costo di compromessi, come abbiamo visto nei genitori e nei fratelli che suggerivano alle ragazze di casa di vendersi ad alto prezzo. Non solo così si diffonde l’idolatria del “fare soldi” e del “fare quello che si vuole”, che Gesù indica come la vera alternativa a Dio (“o Dio, o mammona”), ma la stessa CEI da anni, soprattutto nelle Settimane Sociali, insiste sul primato del “bene comune” come impegno specifico dei cristiani! E invece i giovani hanno poche speranze di un lavoro stabile, gli operai – soprattutto se donne – non sono difesi dai ricatti dei “padroni”, mentre gli stessi immigrati sono respinti, sfruttati, troppo spesso ricattati perché, se “in nero”, non possono protestare: giustamente Lei si richiama alla speranza che viene da Cristo, ma questa va “incarnata” nella vita concreta.
All’indignazione Ella contrappone la sofferenza, e la richiede in primo luogo per la persecuzione dei cristiani; credo che se silenzi ed esitazioni ci sono stati lo siano stati in primo luogo dal Governo, preoccupato per eventuali ricadute economiche o politiche. Ed anche la libertà dei cristiani e delle loro opere va rivendicata come uguaglianza ma senza privilegi, proprio per il compito che la Chiesa ha assunto nel Concilio di farsi promotrice di libertà e di sviluppo per tutta l’umanità.
So, caro Vescovo, che la Sua difesa del Governo interpreta il sentimento di una certa parte del mondo cattolico; credo però che essa debba tener conto delle tante contraddizioni che questo ignora – anche per la manipolazione dei media – e che rendono così sconcertata e sofferente tanta parte dello stesso mondo cattolico, proprio anche per certe presunte coperture di noi Vescovi.
Con fraterno augurio per la Sua diocesi – dei cui ho avuto compagni di scuola nel Seminario Regionale di Bologna – in particolare per la imminente Visita del S. Padre.
+ Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea
domenica 13 marzo 2011
Un invaso di diritti
di Raniero La Valle
Ha perfettamente ragione il ministro Maroni quando dice che la marea di profughi è tale che non la si può considerare solo un problema dell’Italia, né tanto meno di Malta, ma che è un problema
sabato 26 febbraio 2011
Il mio novecento

di Raniero La Valle
Il discorso di Raniero La Valle per la festa dei suoi 80 anni
LECTIO DISCIPULARIS
A Antigone, Vasti, Agnese, Agata, Teresa, Tina Anselmi, Ruth First, Marianella, le madri di piazza di Maggio, le donne del 13 febbraio e a tutte le donne che resistono ai potenti
Prima di tutto devo spiegare la curiosa definizione data a questo mio inusuale discorso. Il termine “discipularis”, aggettivo di “discipulus”, è attestato in un codice medievale, nel Carme di un monaco dell’abbazia di San Salvatore telesino, e ricorre due volte nella Patristica latina, ma non si trova affatto nei dizionari. E quando manca la parola, vuol dire che manca anche la cosa. Invece il termine “magistralis” si trova sempre, segno che di maestri ce ne sono tanti, e c’è sempre qualcuno che fa una “lectio magistralis”. Ciò vuol dire che la nostra società, benché dicasi cristiana, ha del tutto dimenticato o rimosso la parola evangelica che dice: “non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro” (Matteo, 23, 10).
Stasera io vorrei dire invece la mia esperienza di discepolo; e benché io abbia avuto molti maestri, vorrei parlare di quella scuola e di quel maestro di cui soprattutto sono stato discepolo, cioè del Novecento, del “mio” Novecento, della storia che esso è stata, per me ma anche per tutti.
Il Novecento è stato un secolo grande e terribile, affascinante e tremendo, tempo di morti e di rinascite. È il secolo che ha prodotto i totalitarismi e il costituzionalismo, che ha fatto le più grandi guerre e ha dato fondamenti alla pace, che ha inventato la bomba atomica e la dottrina della nonviolenza, che ha perpetrato la shoà, ha compiuto genocidi e ha visto popoli insorgere e liberarsi.
Per fortuna non è stato un “secolo breve”, come certi storici hanno sostenuto e così io, che ne ho attraversato gran parte, ho avuto una vita più lunga.
Il fascismo
Per me, il mio Novecento è cominciato nella notte del fascismo; ma essendo un bambino non ne sono stato, all’inizio, troppo turbato. È vero che sono stato balilla, e perfino balilla moschettiere, ma non ho fatto a tempo a diventare avanguardista, prima che il fascismo cadesse.
Forse ho fatto anche qualche tema sul duce. Il Duce era un mito. Ed io ricordo il mio choc quando per la prima volta mi sono imbattuto in un atto di demitizzazione. Fu quando su un manifesto affisso per la strada, abbastanza in basso perché un bambino potesse arrivarci, vidi scritto in un angolo, piccolo piccolo, a matita: Abbasso il duce. Mi fece un’impressione straordinaria. Dunque si poteva anche essere contro il duce? Dunque nel segreto si poteva pensare male di lui? Dopo di allora, molti altri processi di demitizzazione sono entrati nella mia vita; ma quella fu la prima volta, e ancora me ne ricordo.
Il fascismo, nel quale avevo vissuto lietamente l’infanzia, cominciò a farmi soffrire quando ho smesso di essere un bambino. Ciò è accaduto all’età di otto anni, quando è morto mio padre, una firma importante del giornalismo, Renato La Valle, che però il regime da anni aveva messo a tacere. Ho smesso di essere un bambino anche perché subito dopo, nel 39, c’è stata la guerra, e la guerra non fa bene ai bambini. A Roma venne anche la fame; sicché quando toccava a me di andare a prendere il pane dal fornaio, che si chiamava Biagini, già per la strada mangiavo il panino che mi spettava, che era poi la razione di cento grammi di pane al giorno stabilita dal governo.
In ogni caso non si poteva affrontare la guerra da bambini, con una madre vedova e due sorelle, Fausta e Fidelia, anch’esse bambine. Vennero anche i bombardamenti a Roma; nella strada accanto alla nostra morì Virginio Gaida, che era direttore del “Giornale d’Italia”, e la fontana di fortuna sotto casa, attaccata alla presa per innaffiare, fu colpita mentre le donne erano in fila per prendere l’acqua. Un signore ebreo, che ci dava lezioni di francese a domicilio, fu ben presto in pericolo, sicché noi lo nascondemmo in casa nostra, anzi gli cedetti il mio letto, che aveva una coperta di damasco rosso fatta da una tenda. Seppi così che gli ebrei erano perseguitati. Una notte sparì, fuggito altrove; nel cestino della carta trovai che aveva buttato con noncuranza una cravatta ancora buona, perché era un barone. Poi abbiamo saputo che si era salvato.
Così cominciai a capire molte cose della guerra. Per esempio che cosa era una guerra mondiale. La guerra mondiale era che il Brasile, chissà perché, era nostro nemico. Ma il Brasile per noi era la fonte di sostentamento, perché mia madre lavorava col Brasile. Era infatti corrispondente di giornali brasiliani; e ciò lo si deve al fatto che alla morte di mio padre genialmente si era fatta giornalista; aveva passato una vita a battere a macchina gli articoli di suo marito, che scriveva solo a mano, e grazie a quella macchina aveva acquisito un sapere che le venne buono al momento del bisogno, permettendole di ereditare il posto di lui e di continuare il suo lavoro: ed ecco che ora la guerra separava lei dal suo lavoro, e noi dal suo stipendio.
Così lei, Mercedes, dovette inventarsi altri lavori; non poteva più scrivere articoli, però poteva fare la dattilografa; e così ancora una volta la macchina da scrivere la salvò.
Degli avvocati, che patrocinavano presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, le diedero da copiare dei processi; e lei ogni mattina andava al palazzo di giustizia a scrivere, e ci andavo anch’io, perché anch’io nel frattempo avevo imparato a scrivere a macchina, e perciò copiavo le carte dei processi anch’io; per fortuna allora non c’erano impedimenti al lavoro minorile.
Fu in questo modo singolare che io, senza affatto capire di che si trattasse, ho incrociato il dramma dell’antifascismo, e forse ho scritto a macchina qualche difesa di antifascisti giudicati dal Tribunale Speciale, e qualcuno magari condannato a morte. Ed è forse da questo inconscio in cui è rimasto in me sepolto il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che oggi nasce la mia indignazione quando vedo accusare e diffamare i tribunali e i giudici della Repubblica democratica.
Il fascismo andò a finire nell’occupazione tedesca. E io ricordo i tedeschi che facevano le retate; capitò anche a me, quando a Porta Pia ci fecero scendere da un autobus, che allora non si chiamava 60, ma NT, che voleva dire Nomentano-Trastevere, e presero gli uomini; io avevo tredici anni, e perciò non corsi nessun pericolo, Nondimeno la domenica, quando andavo col mio compagno Giorgio Marino alle Messa e alla dottrina dal Cardinale Massimi, nella chiesa di San Claudio a piazza San Silvestro, il cardinale ci prendeva in macchina con sé e ci portava fino a casa sua per non farci correre rischi.
Anche il cardinale Massimi, che apparteneva a una famiglia di principi romani, era un demitizzatore. Girava sempre in tonaca nera, senza porpora, come un prete qualunque; e ricordo il mio stupore una volta che in San Pietro, nella cerimonia del concistoro, lo vidi sfilare, come usava allora, con uno strascico di tredici metri.
Faceva gesti semplici e omelie antifasciste. La domenica, prima di lasciarmi, spariva nell’androne della villa che abitava ai Parioli, e tornava, con la sua andatura caracollante, portandomi un cartoccio di farina e un sacchetto di zucchero, perché ero orfano; e siccome era uno che non cambiava abitudini – al Concilio certamente sarebbe stato tra i conservatori – continuò per molti anni ogni domenica a regalarmi sacchetti di zucchero e un chilo di farina, anche quando la guerra era finita e noi non ne avevamo più bisogno.
La Costituzione
Fu Vittorio Bachelet, che era un po’ più grande di me, che dalla Congregazione del cardinale Massimi mi portò alla FUCI, la Federazione degli universitari cattolici. Bachelet voleva lasciare la carica che aveva lì, di segretario del Consiglio Superiore, per cominciare la sua strada professionale che doveva portarlo poi fino al palazzo dei Marescialli e al sacrificio della vita. Lasciando la FUCI, volle lasciare la sua carica a me che non ero nemmeno fucino; sicché entrai alla FUCI dal vertice, al centro, invece che dalla base. Lì mi imbattei in un altro processo di demitizzazione. Fu quando, parlando con Ivo Murgia, che della FUCI era stato un prestigioso presidente, gli sentii fare una critica al papa, che chiamò “l’uomo vestito di bianco”. Ne fui molto impressionato. Dunque si poteva parlare così di Pio XII? Dunque anche lui era un uomo come gli altri, tanto che a distinguerlo potesse essere il suo abito bianco?
La FUCI rappresentò per me, come per molti altri giovani, la vera figura della Chiesa. Un po’ libera e un po’ clericale, molto seria e molto allegra, studiava e cantava, era intellettuale e sentimentale. C’era molto Maritain, che a me non piaceva per quella storia di dividere i piani tra lo spirituale e il temporale, tra l’operare come cristiani e l’operare come cittadini. Ma soprattutto era una grande comunità di amici: se la Chiesa era quella, era una meraviglia. Era anche il luogo dove ci si innamorava e ci si sposava, come ho fatto anch’io; e i matrimoni duravano “fino a che morte non ci separi”, cosa che a me accadde dopo quarant’anni.
La FUCI fu anche l’iniziazione alla politica, attraverso l’impegno nella democrazia universitaria. Io non sapevo nulla di politica, in FUCI non se ne parlava. A noi, gruppo dirigente di allora (presidente era Romolo Pietrobelli), non sarebbe mai venuto in mente di promuovere una campagna referendaria per cambiare legge elettorale e sistema politico, per spiantare i partiti e fare un’Italia bipolare maggioritaria e manichea, come poi si è fatto. Vero è che anche allora la politica si faceva, ma la faceva don Costa, che era un grande assistente ecclesiastico dell’associazione; ma dal punto di vista ecclesiale non era molto meglio che a farla fosse solamente lui. Egli parlava con i capi democristiani; una volta andò in via don Orione da don Sturzo a nome del papa, a dirgli che non doveva più scrivere, perché i suoi articoli sul “Giornale d’Italia” erano troppo antidemocristiani, e se la prendeva troppo con le partecipazioni statali e con l’ENI di Enrico Mattei. L’obbedienza che chiedeva a Sturzo, e proprio a lui, era il silenzio.
Io allora non sapevo che in quegli anni, tra la fine della guerra e il mio ingresso all’università, c’era stato un passaggio d’epoca. Certo, conoscevo i fatti, ma non ancora la loro portata.
In effetti in quegli anni, con l’Assemblea di San Francisco, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le Costituzioni, il Novecento aveva cambiato il suo volto, aveva segnato una svolta nella storia e nel pensiero dell’Occidente, e aveva cambiato il nostro destino.
Il Novecento, e con esso l’Italia, avevano avuto il loro momento magico, avevano operato una straordinaria conversione culturale, politica e morale. Gli orrori della guerra, gli esiti perversi in cui erano venute a concludersi le dottrine politiche e antropologiche della modernità, avevano fatto cadere tutte le certezze, avevano posto l’esigenza potente, incoercibile, di pensare tutto di nuovo, l’uomo, lo Stato, la guerra, la pace, il diritto, l’ordine delle nazioni, ben al di là dell’antifascismo.
Il “mai più” pronunciato sotto lo scrosciare delle bombe, nei campi di sterminio, nelle carceri della tortura, dinanzi ai venti milioni di morti solo nell’Unione Sovietica, dinanzi allo stupro dei popoli fatto da colonie ed imperi, doveva trovare la sua traduzione in culture ed ordinamenti nuovi.
Fu così che nella storia del Novecento irruppe la novità della grande Costituente mondiale da cui nacque la Carta dell’ONU del 45, irruppe la novità del costituzionalismo come teoria dello Stato, e in Italia la novità della Costituzione e della Repubblica.
Il rovesciamento, almeno in via di principio, rispetto a tutta la storia passata, non poteva essere più radicale. E ciò almeno sotto tre profili.
1) Se prima il pensiero della disuguaglianza aveva fondato il dominio, ecco che ora veniva proclamata l’eguaglianza. In tutta la storia, fino a Hegel, a Spencer, a Nietzsche, a Croce e perfino nel dizionario francese Larousse e fino a Hitler, era stata teorizzata la disuguaglianza per natura degli esseri umani, la differenza tra popoli della natura e popoli dello spirito, tra spagnoli ed indios, tra razze bianche e nere, tra forti e deboli, tra maschi e femmine, tra uomini e no. Ed ecco che nel 45 eguaglianza e unità di tutta la famiglia umana vengono proclamate come principi generali e universali e come tali entrano nel diritto.
2) Se prima la guerra era stata proclamata dai filosofi madre e principio di tutte le cose, era stata la sposa indissolubile dello Stato sovrano, aveva giudicato i popoli con la forza e non con la giustizia, e fino a Norimberga era stata giudicata legittima anche nelle forme dell’aggressione e dell’invasione, ecco che ora la guerra veniva ripudiata come una spregevole concubina, veniva esclusa dal diritto e proibita nella comunità internazionale perfino nelle sue premesse, con il divieto non solo del ricorso alla forza, ma anche della minaccia dell’uso della forza.
3) Se prima l’idea di sovranità, come di un potere che non riconosce sopra di sé nessun altro potere, aveva fondato gli assolutismi e attribuito agli Stati il diritto di guerra, ecco che ora essa veniva ridimensionata, resa relativa. La sovranità esterna degli Stati era rovesciata nell’interdipendenza, sottoposta al diritto internazionale cogente e addirittura fatta oggetto di rinuncia, come nella Costituzione italiana, al fine di costruire un ordinamento di giustizia e di pace tra le Nazioni; e la sovranità interna veniva strettamente condizionata al costituzionalismo, e ciò a valere sia per i cittadini che per gli stranieri, sicché la cittadinanza, come dice Ferrajoli, è l’ultima discriminazione che dovrebbe cadere.
Certo, questi principi erano ben lungi dall’attuarsi. Però stabilirono un traguardo. Alla Costituente i partiti di massa e i professorini ce la misero tutta per fare della Repubblica il soggetto a cui fossero intestati questi ideali, e ci riuscirono; e i dossettiani ce la misero tutta per fare della Democrazia Cristiana lo strumento per la loro attuazione, finché, non riuscendoci, Dossetti si ritirò dalla scena.
La comunicazione politica era però ancora ristretta, la televisione non c’era, ed io non sapevo nulla di Dossetti. Una volta sentii Franco Grassini, che sarà poi un ottimo capo della GEPI, che diceva di essere “un dossettiano spinto”; solo dopo ho capito che cosa, allora, questo volesse dire.
La politica fu invece per noi la partecipazione agli organismi rappresentativi dell’Università: fu l’Interfacoltà, l’Unuri; i cattolici stavano nell’Intesa universitaria, Pannella era coi goliardi. C’erano pure i comunisti, freschi di scomunica; ma non mi sembrava che mangiassero i bambini. C’era anche Luciana Castellina, che era bellissima e diceva cose ragionevoli e giuste, e naturalmente me ne innamorai, anche se solo nel pensiero.
Del resto io non sono mai riuscito a vedere nessuno come nemico. Una volta, quando più infuriava la lotta contro i comunisti, e Gedda voleva fare una “base missionaria” in ogni condominio per combatterli meglio, io scrissi su “Ricerca”, che era il giornale della FUCI, un articolo dicendo che nel Vangelo si leggeva che bisogna amare i nemici e perciò, benché nemici, bisognava amare anche i comunisti. Successe un putiferio; i Comitati Civici accusarono la FUCI di rompere il fronte, ma in quella occasione don Costa mi difese.
La FUCI mise in movimento un processo di maturazione della fede, che però non si sarebbe mai compiuto se non fosse giunto il Concilio Vaticano II. Io la fede l’accettavo così come veniva proposta, però c’era un disagio che non sapevo decifrare, che mi portava a preferire l’approccio monastico dei camaldolesi; amavo padre Benedetto Calati e una volta restai folgorato quando, ascoltando un’omelia del cardinale Lercaro durante un congresso fucino a Bologna, mi sembrò di sentire per la prima volta parlare di Dio. Lercaro non era il mio vescovo, ma io da allora lo presi come tale, finché quando poi andai a Bologna a lavorare, mio vescovo diventò davvero.
Il Concilio
La figura di Dio che la Chiesa allora proponeva, e la dottrina di fede nella quale lo includeva, erano molto diverse da quelle che sarebbero state dopo il Concilio e quali sono ora. E bisogna ricordarlo, altrimenti non si capisce uno dei cambiamenti più profondi che sono avvenuti nel Novecento.
Nella presentazione che allora se ne faceva, Dio era un nume offeso che doveva essere placato dai nostri sacrifici, così come aveva voluto essere placato dal sacrificio del Figlio che a questo scopo avrebbe mandato a morire sulla croce; la nostra cattiveria era data per scontata e attendeva solo di essere perdonata; il giogo del peccato ci teneva sotto il peso della vecchia servitù, perfino la morte era per colpa nostra, altrimenti saremmo stati immortali, il mondo era una valle di lacrime, noi dovevamo disprezzare le cose terrene e le prosperità del mondo, e cercare solo quelle celesti. Le nostre afflizioni erano del tutto meritate, come dicevano le preghiere della Messa: “Dio che vedi come per le nostre perversità siamo afflitti”; “Noi che giustamente siamo afflitti a causa dei nostri peccati”; “Noi che siamo afflitti a causa del nostro operare”; “Noi incessantemente siamo afflitti a causa dei nostri eccessi”, e così via, di colpa in colpa. Così si pregava nell’Ordinario latino della Messa prima della riforma liturgica del Concilio; e siccome eravamo stati educati a prendere in mano il messale e sapevamo il latino, capivamo quelle parole e ora possiamo capire il salto che c’è stato, e possiamo anche capire il furore dei tradizionalisti che vogliono tornare a quella messa, e non perché è in latino.
All’origine di quella comprensione della fede c’era un’antropologia pessimistica, che era diventata cultura comune e che ancora oggi possiamo rintracciare alla base di molte istituzioni dell’Occidente, a cominciare dallo Stato. Esso fu concepito infatti come antidoto alla congenita cattiveria umana che di per sé porterebbe alla violenza generalizzata, alla lotta di tutti contro tutti, sicché anche la politica è stata teorizzata come uno scontro tra Amico e Nemico. Il nostro acerrimo sistema bipolare è ancora il figlio di questa dottrina.
Secondo questa antropologia, l’uomo si era infortunato appena creato; a causa del peccato era rimasto sfigurato, la sua natura decaduta, ferita; il paradiso terrestre c’era stato davvero, ma ne eravamo stati cacciati. La libertà dei moderni era considerata un delirio. L’eguaglianza tra uomo e donna un’eresia e anzi, secondo Pio XII, una tentazione diabolica, la lusinga di “una voce serpentina”. Il desiderio sessuale, i parti con dolore, il lavoro col sudore della fronte erano pena del peccato; l’amore sponsale non inteso alla procreazione era, come si leggerà in un documento preparatorio del Concilio, “un fetido onanismo coniugale”.
Rievocando quei tempi, nel 1979 a quindici anni dalla chiusura del Concilio, il teologo Karl Rahner dirà che la Chiesa era tributaria di un cattivo agostinismo per il quale la storia del mondo era ed è “la storia di una massa dannata nella quale solo a pochi è dato salvarsi per una grazia di elezione raramente concessa”; quei pochi stavano nella Chiesa cattolica, fuori della quale non c’era salvezza; quanto agli altri cristiani erano considerati come “una massa di eretici da indurre con le buone o con le cattive alla conversione all’unica vera Chiesa”.
È su questo scenario che irrompe il Concilio, che papa Giovanni inaugura postulando l’aggiornamento della Chiesa, il licenziamento dei profeti di sventura, il balzo innanzi nella penetrazione dottrinale e nella formazione delle coscienze secondo il linguaggio e le forme dell’indagine proprie del pensiero moderno. E benché oggi molti si ostinino a dire che il Concilio non ha cambiato niente, o che deve essere interpretato secondo un’ermeneutica dell’invarianza, la Chiesa e il suo annuncio di fede ne sono usciti trasformati; come dice Rahner, lo stesso annuncio di Cristo è diventato un annuncio nuovo; “sia nell’annunciatore che nell’annuncio è avvenuto qualcosa di nuovo, di irreversibile, di permanente.”
Queste cose non le abbiamo scoperte subito, ma nel tempo, e per molti cristiani sono ancora da scoprire.
Ma certamente il Dio testimoniato dal Concilio non è un Dio vendicatore che debba essere risarcito e placato con l’olocausto del Figlio; l’età dei sacrifici è conclusa, e con essa qualunque legittimazione religiosa delle pratiche vittimarie, delle vendette del sangue, delle rappresaglie, della violenza e della guerra. La parola “placatio”, da “placare”, non c’è mai nei testi del Concilio né nella liturgia dopo il Concilio. Il Signore è stato crocefisso non a causa di Dio e per far piacere a lui, ma a causa degli uomini, a cui egli ha pagato fino alla fine il prezzo del suo amore per loro.
Il Dio del Concilio non è il Dio bifronte, “tremendum et fascinans”, di cui parlava Rudolf Otto all’inizio del Novecento, ma è un Dio solo fascinans, solamente buono. È un Dio che non ha cacciato nessuno dal giardino dell’Eden dopo il peccato; nella narrazione della storia della salvezza fatta dal Concilio questa cacciata non c’è; la buona notizia è che questa notizia non c’è, e anzi, dice il Concilio, gli uomini, caduti in Adamo, Dio non li abbandonò, non dereliquit eos, ma a causa di Cristo sempre prestò loro gli aiuti necessari per salvarsi e senza posa, sine intermissione, si prese cura del genere umano.
Di conseguenza l’essere umano non è un fuscello sbattuto nel tempo, ma ce la può fare a prendere in mano la storia, ad aggiustarla (ius, il diritto, viene da iustari, che vuol dire aggiustare). Il Figlio di Dio si è unito in qualche modo ad ogni uomo, dice il Concilio, perciò la salvezza è per tutti, e tutti possono cooperare a realizzarla, perché, dice con la Bibbia il Vaticano II, “Dio ha messo l’uomo in mano al suo consiglio”, e nella misura in cui vengano “suscitati uomini più saggi” è possibile far fronte a una situazione in cui, come dice la Costituzione pastorale, “è in pericolo il futuro del mondo”. E quanto alla libertà, essa è la “dignitas humana”, la dignità stessa dell’uomo, e in nessun modo la si può coartare, nemmeno col pretesto di non dare libertà all’errore. La riconciliazione della Chiesa col mondo, celebrata dal Concilio, è stata in realtà una riconciliazione con l’uomo, con gli uomini e le donne quali noi siamo; e da questo non si può tornare indietro.
Il giornale
Quando arrivò il Concilio, io ero da poco tempo direttore dell’ “Avvenire d’Italia”, un giornale cattolico un po’ abbandonato dopo la lunga direzione di Raimondo Manzini, passato all’“Osservatore Romano”.
Prima, per alcuni mesi, ero stato direttore del “Popolo”, dopo il mitico Bernabei, sotto la guida di Aldo Moro. Ma non volevo fare la carriera nei giornali di partito, e non ero iscritto alla DC, forse ero indipendente già allora, e perciò accettai l’offerta, liberatoria, che mi venne dal giornale di Bologna. Credo che ne avessero parlato con Giovanni XXIII perché Angelo Salizzoni, l’esponente moroteo che faceva parte del Consiglio d’Amministrazione del giornale, mi comunicò la nomina dicendomi: “per lei si apre anche il portone di bronzo”. Bernabei, che intanto si stava inventando la televisione, mi diede il suo viatico con un consiglio: “Ricordati – mi disse – che una fotografia in prima pagina gli piace perfino a La Pira”. Io avevo trent’anni.
All’ “Avvenire d’Italia” ho fatto l’esperienza di che cosa volesse dire davvero la libertà di stampa. Con giornalisti grandi come Piero Pratesi, Albino Longhi, Giancarlo Zizola, Vittorio Citterich, Umberto Andalini, Italo Moscati, Cavallaro, Pecci, Nanetti e molti altri, e con collaboratori illustri, di cui Bologna non era avara, da Andreatta ad Alberigo a Ulianich alla Codrignani ai due Prodi, facemmo proprio il giornale che volevamo fare. I vescovi ci lasciavano liberi, e il cardinale Lercaro garantiva per tutti. L’unico fastidio che ogni tanto avevamo era quando un vescovo voleva che non mettessimo la pubblicità dei film che il Centro Cattolico cinematografico di allora giudicava esclusi ai minori.
Nel 1964 Paolo VI, che era antifascista, chiuse il “Quotidiano” di Gedda, che era il giornale cattolico di Roma, e assegnò all’ “Avvenire d’Italia” la sua area di diffusione a Roma e nel Sud, sicché il giornale divenne il quotidiano nazionale dei cattolici; nello stesso tempo, Paolo VI pagò l’abbonamento al giornale per tutti i Padri conciliari, durante le sessioni del Concilio. Per il giornale fu un’esperienza esaltante: i vescovi cambiavano la Chiesa, e noi raccontavamo ai fedeli il Concilio che cambiava la Chiesa; nello stesso tempo raccontavamo ai vescovi il loro stesso Concilio e il modo in cui esso era percepito nella base ecclesiale, sicché si creò un circuito virtuoso tra padri conciliari, giornale e opinione pubblica nella Chiesa.
Quando il Concilio finì, e Roma fu di nuovo sola, il vento cambiò. Anche la proprietà del giornale era cambiata, e non era più in maggioranza dei vescovi locali e dei laici, ma della Santa Sede. E perciò si pose un problema nuovo: che ne è della libertà di stampa quando l’editore è il papa? Con Paolo VI le cose erano andate sempre bene, tranne in due occasioni. La prima fu nel 1964 quando nelle elezioni per il presidente della Repubblica la DC proponeva Leone, e spuntò la candidatura Fanfani, cosa che oltreTevere fu considerata una disobbedienza. I giornali cattolici avrebbero dovuto sostenere questa tesi. Anzi avremmo dovuto dire che Fanfani era un pubblico peccatore, perché mentre la Chiesa chiedeva l’unità degli elettori cattolici, lui rompeva l’unità degli eletti. Noi non sostenemmo questa idea, e continuammo a dire che, Costituzione alla mano, Fanfani aveva tutto il diritto di proporre la sua candidatura. Una sera, anzi di notte, fui chiamato a Roma e mi fu detto autorevolmente che il giornale doveva cambiare linea, non perché a chiederlo era il papa che era il papa, ma perché a chiederlo era il papa che era l’editore. Ne fui sconcertato, e da quel momento ci limitammo a pubblicare l’ANSA, senza commenti; e alla fine fu eletto Saragat.
La seconda volta, più grave, fu a causa della guerra del Vietnam. Noi criticavamo i bombardamenti americani sul Vietnam del Nord, e dicevamo che in tutti i modi si dovesse invece negoziare. La Santa Sede non voleva condannare i bombardamenti, con l’argomento che anche i Vietcong combattevano, e perciò la Chiesa doveva essere equidistante, non poteva stare né con gli uni né con gli altri. Per parte nostra il né, né non ci piaceva e preferivamo il sì sì, no no: i bombardamenti non si dovevano fare. Anche allora ci fu chiesto di cambiare linea; io dissi che non potevamo, perché era una questione di coscienza; mi fu risposto che anche il papa aveva una coscienza; certo, solo che il direttore del giornale non era il papa: quale era allora la coscienza in gioco?
La questione della libertà del giornalista si poneva così in modo inedito. Che cosa succede a un giornalista cattolico quando l’editore è il papa? Qui entrano in conflitto non due obbedienze, ma due libertà: una è la libertà del cristiano, che vale sempre, anche nei confronti del papa; l’altra è la libertà del giornalista dipendente, che arriva fin là dove l’editore lo permette. Per me, a prevalere, fu la libertà del cristiano, e l’editore vestito di bianco non ne fu affatto contento. Più tardi quell’editore chiuse l’Avvenire d’Italia, e diede vita a un nuovo giornale, l’Avvenire. Il cardinale Lercaro ne fu molto turbato, ma ben presto ebbe anche lui i suoi dispiaceri. La lotta per il riassorbimento del Concilio era cominciata. Sarebbe durata a lungo. Fu Pino Alberigo con la sua storia del Vaticano II, a predisporre i mezzi di difesa.
Il tempo della crisi
Il Vietnam, la Palestina, l’America Latina, le lotte per la pace, i Tribunali Russell rilanciati da Lelio Basso con Linda Bimbi e le sorelle brasiliane, riempirono gli anni successivi.
Il ’68 fu la terza rivoluzione della seconda metà del 900. Dopo la rivoluzione del diritto, dopo la conversione del linguaggio della fede, venne col 68 la rivoluzione della vita quotidiana, l’esplodere dei movimenti, il nuovo pensiero femminista, il sogno della libertà, la lotta contro le istituzioni totali, la chiusura dei manicomi, il nuovo diritto di famiglia. Il 68 avrebbe dovuto essere letto come un segno dei tempi; ma così non fu letto né dalla Chiesa né dai partiti, e perciò non poté sprigionare tutte le sue energie.
Nel 1974 si ruppe l’unità politica dei cattolici col referendum sul divorzio; i “cattolici del no” con Scoppola, Carniti, le ACLI, le comunità di base rifiutarono il sì all’abrogazione preteso da Fanfani e da Gabrio Lombardi. Dopo una notte di preghiera anche il piccolo fratello di Gesù Carlo Carretto disse che avrebbe votato no per compassione verso gli emigrati italiani in Germania rimasti senza famiglia e senza amore.
A causa dell’esito del referendum il sistema di potere si incrinò; la democrazia bloccata dalla clausola di esclusione dei comunisti rischiava di non poter essere più nemmeno democrazia. Senza i comunisti, non aveva i numeri. Era venuto dunque il tempo di mettere il dialogo alla prova, come aveva scritto Mario Gozzini: coi comunisti si poteva parlare, e perfino giungere a fare una maggioranza parlamentare con loro. Alla Badia Fiesolana, nel 1976, ospiti di padre Balducci, ci ritrovammo in un centinaio per decidere il da farsi. C’era un invito del PCI a entrare nelle sue liste come indipendenti. Tutti erano d’accordo; alcuni però preferirono continuare il lavoro da intellettuali, altri decisero di mettere le idee nella mischia, di esporsi in prima persona. Non erano solo cattolici: fu decisiva la scelta del pastore Vinay. Nacque così la componente cristiana della Sinistra Indipendente che raggiunse in Parlamento il sen. Ossicini, l’ultimo erede della Sinistra cristiana, e che divenne un punto di riferimento nel dibattito culturale e politico del Paese.
In Parlamento il battesimo del fuoco arrivò per me, appena eletto, con la legge sull’aborto. Bisognava uscire dal sistema carcerario e clandestino previsto dal codice Rocco; ma non potevamo nemmeno ammettere la liberalizzazione ideologica dei radicali. Perciò cercammo una soluzione conforme alla Costituzione ma non dimentica del Vangelo, il che voleva dire che contrastava con quella di tutti i gruppi parlamentari, dai democristiani ai comunisti. Il confronto fu molto duro, ma infine riuscimmo a mettere nella 194 quelle cose che nel gennaio scorso la Chiesa ortodossa ha chiesto al governo Medvedev di mettere ora nella legislazione russa: l’obbligo di una consultazione preventiva con la donna, la ricerca di alternative all’aborto, l’introduzione di un consenso informato e di un tempo di riflessione, nonché la creazione di “centri di crisi”, che noi chiamavamo consultori, nelle cliniche ostetriche. Per queste proposte il Patriarcato di Mosca è stato ora molto apprezzato a Roma e dall’agenzia di stampa della Santa Sede, mentre allora poco ci mancò che partissero le scomuniche, per non parlare della lapidazione quotidiana da parte dell’ “Avvenire”.
In quella legislatura Moro, che aveva osservato come nelle elezioni del 1976 c’erano stati due vincitori, la Democrazia Cristiana e il Partito comunista, cominciò a tessere la sua tela per giungere a una democrazia compiuta, superando l’esclusione che metteva fuori gioco un terzo dell’elettorato. L’America non voleva, e c’era in Italia chi minacciava di scendere con le armi nella strada, se i comunisti fossero stati ammessi al governo.
Ma le armi già le avevano le Brigate Rosse; e lo sbarramento, interno e internazionale, ad una intesa coi comunisti fu tale che Moro fu ucciso, complice la linea della fermezza che lo votò al sacrificio. Io gridai contro la ragion di Stato che ripeteva la sentenza di Caifa per la quale “è bene che un uomo solo muoia per il popolo”, ma il rombo della fermezza coprì ogni voce alternativa.
Fu lì che morirono anche la Democrazia Cristiana e il Partito comunista, pur se la loro agonia si protrasse nel tempo. L’ultimo guizzo profetico venuto dalla DC furono il 26 luglio 1990 le dimissioni dal governo Andreotti di cinque ministri della sinistra democristiana (Martinazzoli, Fracanzani, Misasi, Mattarella e Mannino) per protesta contro la fiducia pretesa da Craxi sulla legge Mammì; era la legge che consegnava tutte e tre le reti televisive e un enorme gettito pubblicitario a Berlusconi, che Martinazzoli accusava di essere un “capitalista da Far West”; ma il fedele Confalonieri replicava che andava bene proprio così, che John Ford e il Far West erano la metafora del progresso. Quanto a noi, l’ultima cosa che facemmo fu la nuova legge sull’obiezione di coscienza, talmente bella che subito dopo per rivalsa abolirono il servizio militare obbligatorio.
Morendo la DC e il PCI, morivano anche le prospettive, forse troppo ambiziose, di imprimere un corso diverso alla storia del mondo. La speranza era stata che, a partire dal caso italiano, lo scontro tra le due culture, occidentale e comunista, potesse non risolversi nell’annichilimento dell’una o dell’altra, ma nella ricomposizione dell’unità umana, nel trascendimento degli opposti, nell’incontro fecondo tra le due culture e anzi tra tutte le culture.
Invece si partì con la corsa al riarmo nucleare, i missili, Comiso, e quando, nonostante il tentativo di Gorbaciov, lo Stato sovietico crollò, il ministro degli esteri De Michelis venne in Parlamento a dire che la guerra fredda era finita e che noi l’avevamo vinta.
Non sapeva che a finire non era solo l’utopia comunista, ma anche il sogno occidentale di una democrazia realizzata, dove la politica moderasse l’economia, il costituzionalismo garantisse i diritti e tenesse entro limiti invalicabili il potere, la giustizia fosse realizzata, e le Repubbliche togliessero gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana.
Il Novecento finì così con una sconfitta. Non vinse né il socialismo né il costituzionalismo liberale; si ripeté il fato che sempre ritorna, del né né: né con lo Stato, né con le Brigate Rosse, né col comunismo né con la democrazia, né con Berlusconi né con i suoi giudici.
Invece venne ripristinata la guerra, il ripudio venne revocato; si cominciò con la guerra del Golfo. Poco prima che cominciassero i bombardamenti, con un gruppo di parlamentari andai a Bagdad, contemplai la città che stava per essere distrutta, e mi feci tradurre in arabo una lettera da far giungere nelle mani di Saddam Hussein, in cui lo scongiuravo, per il suo popolo, per i palestinesi, per la pace, in nome di Allah, di evitare la guerra con gli Stati Uniti: noi sapevamo quale fosse la potenza militare americana, e che cosa poteva voler dire cadere sotto il suo fuoco.
Poi ci fu la guerra con la Iugoslavia, la NATO si propose come nuovo sovrano militare mondiale; a Belgrado, dove ero andato con un una delegazione di “un ponte per”, che portava aiuti, rischiammo di cadere sotto il fuoco amico la notte in cui gli americani, che già avevano distrutto la Zastava e i ponti sul Danubio, bombardarono per soprappiù l’ambasciata cinese e l’albergo Iugoslavia che avevamo appena lasciato.
I guai vennero poi a cascata. Rilegittimata sul piano mondiale la violenza, in Israele si fece strada l’idea che, pur senza la pace, i palestinesi avrebbero potuto cessare di essere un problema; l’Europa, che era stata la grande costruzione ideale e politica del secolo, non ebbe voce, si infilò nelle maglie economicistiche di Maastricht. In Italia cominciò la demolizione della Costituzione; la democrazia rappresentativa, che finalmente avrebbe potuto funzionare essendo venuta meno la “conventio ad excludendum” dei comunisti, fu abbandonata per essere sostituita alla fine con un Parlamento del principe in un sistema bipolare selvaggio, e cominciò la guerra contro i giudici perché non avesse mai più a ripetersi Mani Pulite e i politici infedeli potessero procacciarsi l’impunità.
Quando finì il Novecento, finì anche il Millennio. A Roma, come assessore, avevo organizzato un convegno internazionale nel quale avevamo posto la domanda: che cosa di buono e salutare del Novecento dobbiamo portarci dietro nel nuovo millennio, e che cosa dobbiamo abbandonare, perché non ritorni mai più?
Questa domanda vale anche oggi, quando la situazione è assai grave, il Novecento è rimasto incompiuto, la democrazia è interrotta, l’Italia ha smesso di essere felice e un fuorilegge si aggira per l’Europa parlando in nostro nome.
La mia risposta, che ho voluto darvi qui stasera, è che del Novecento restano, insieme a molti altri doni, quelle tre grandi cose che furono la Costituzione, il Concilio, e il 68. Ma nessuna di queste cose potrà sopravvivere, se non sarà assunta con amore, così come per amore sono state compiute. Non c’è dubbio che alla Costituente uomini come Moro, Dossetti, Basso, La Pira, Lazzati, Calamandrei, e donne come Laura Bianchini, Angela Gotelli, Teresa Mattei, operarono per amore. Non c’è dubbio che Giovanni XXIII ha osato il Concilio per amore. E il ’68 è stato l’utopia dell’amore come alternativa al potere. Oggi si può anche difendere la Costituzione, come noi facciamo, ma senza un amore che abbia l’assillo del bene comune di tutti i cittadini, essa è destinata a sfiorire e a cadere a pezzi, ben oltre l’art. 41; oggi un papa potrà pure rendere formale omaggio al Concilio, ma se non lo assume con amore, anzi con passione, non potrà dare nuova vita alla Chiesa; oggi il 68 è dimenticato e da molti perfino esecrato; ma se le nuove generazioni si incistano nei loro amori privati, e non riscoprono la dimensione comunitaria, politica e pubblica dell’amore, inaridiranno nei loro egoismi. Come diceva Aldo Capitini parlando della nonviolenza, come di una scelta fatta per amore: “ma è l'amore che non si ferma a due, tre esseri, dieci, mille (i propri genitori, i figli, il cane di casa, i concittadini, ecc.); è amore aperto, cioè pronto ad amare altri e nuovi esseri, o ad amare meglio e più profondamente gli esseri già conosciuti. Perciò non è mai perfetto e non finisce mai”.
Oggi, a dieci anni dall’inizio del nuovo Millennio, siamo preoccupati per i giovani e per i figli dei loro figli che vivranno in questo secolo. Quello che noi possiamo fare è di trasmettere loro gli attrezzi e le speranze che noi abbiano avuto nel Novecento, sapendo però che saranno loro a decidere cosa farne, e anche come dotarsi di attrezzi nuovi. Ogni generazione ha le sue vie. Non si tratta perciò di lasciare ai nostri figli degli altarini alla Costituzione al Concilio e alla contestazione, ma di dire il senso che queste cose hanno avuto per noi. E forse, riecheggiando una vecchia parola, potremmo dirlo così: queste sono le tre cose che rimangono: il diritto, la fede, la libertà; ma di tutte più grande è l’amore.
domenica 20 febbraio 2011
Fonte: Blog di Raniero La Valle